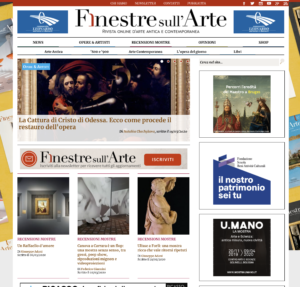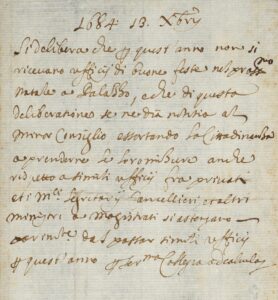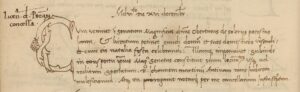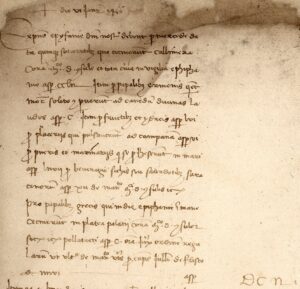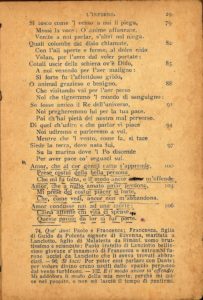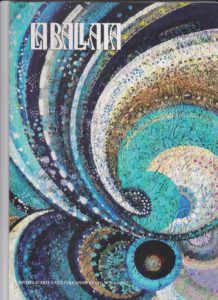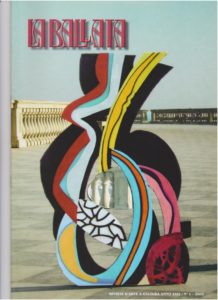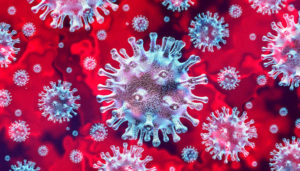Solidarietà Culturale di UniAuser
In questi giorni, sono tante le persone che, con affetto e simpatia, esprimono la loro vicinanza a UniAuser.
I docenti, che ci stanno inviando pensieri, riflessioni, contenuti da condividere con i loro allievi e con tutti gli iscritti, per alleviare la monotonia e l’angoscia di queste giornate di isolamento forzato. I nostri soci, che hanno espresso il desiderio di poter contare sui consigli di lettura e ascolto dei loro insegnanti, e perpetuare così, anche in remoto, la comunità educante di Uniauser.
Questa sezione del sito ospita i contenuti che i nostri docenti invieranno, che saranno segnalati e linkati anche attraverso la pagina Facebook di UniAuser. A disposizione di tutti, non solo dei nostri soci.
Grazie per la vostra vicinanza e per l’aiuto e il sostegno in questo esperimento che mantiene vive non solo la dimensione culturale, ma anche quella relazione tra noi che, sebbene virtuale, ci fa sentire più vicini e meno soli.
Di seguito un link che raccoglie tutte le risorse di rete gratuite scaricabili
l’Arte al tempo del coronavirus








05 Salute, Benessere e Invecchiamento Attivo
Luigi Ferranini
Carissime/i, vi mando per ora materiale , rigorosamente preso dai siti istituzionali, centrato su questi punti:
1. Informazioni generali e risposte alle domande più frequenti
2. Consigli per la comunicazione ai bambini
3. Guida per la gestione dello stress psicologico.
Parto dal credere che vi sia bisogno di informazioni reali e semplici, ma anche di come gestire le emozioni ed i rapporti con i famigliari ( per questo ho scelto i bambini, possibili nipoti).
Nulla quindi di tecnico anche perché ora non navighiamo ancora nelle certezze e molte informazioni si rivelano poi errate.
Un caro saluto.
a) Ufficio per le politiche delle persone con disabilità
b) Massima attenzione ai contagi interfamiliari (Locatelli – CSS)
Gilberto Giaretta
Homo Sapiens
I semiologi, Barthes in particolare, ci hanno insegnato l’importanza dello studio del significato profondo delle parole. Nella nostra lingua udire e ascoltare, conoscere e sapere, vedere e guardare non sono sinonimi; anche ripartire è cosa diversa dal ricominciare. Si riparte dopo una sosta e la strada e la meta sono quelle di prima; si ricomincia quando si capisce invece che la meta è cambiata e che occorrono nuove strade.
Nel momento in cui la nuova pandemia che si profila qui e altrove non è il Coronavirus ma la corsa dissennata verso la Fase Due, vi segnalo quattro storie provate che fanno riflettere sulle capacità razionali e di previsione di Homo Sapiens. Con l’augurio di salvare l’ironia e non ritrovarci in futuro come il “sesto artigliere”, vi saluto cordialmente
Negli anni ’50 un reparto di artiglieria leggera dell’Esercito di Sua Maestà Britannica dette una dimostrazione delle sue capacità ad alcuni alti personaggi politici stranieri. Questi ospiti rimasero molto impressionati dalla velocità e dalla precisione dei serventi ai pezzi. Un partecipante della delegazione, dichiarando tutto il suo interesse, chiese quale fosse il compito del soldato che, mentre i suoi commilitoni eseguivano le manovre, rimaneva immobile e sull’attenti. “E’ il numero sei” rispose in forma sibillina l’aiutante di campo cui era stata rivolta la domanda. “Ho visto che è il sesto, ma perché se ne sta lì impalato?” incalzò il partecipante alla delegazione. “E’ il suo compito. Il numero sei deve rimanere sull’attenti durante tutta la manovra” “Ma allora perché non lasciate solo cinque soldati ad ogni pezzo?” Nessuno seppe dare una risposta. Dopo lunghe ricerche negli archivi militari e nei vecchi manuali di addestramento si scoprì quale era il compito del numero sei. Il soldato numero sei era quello che badava ai cavalli
Gian Carlo Cocco, Management
Malgrado fosse citato già nelle cronache egizie a partire da 1500 a. C. e da Ippocrate nel quinto secolo a.C., lo scorbuto non suscitò particolare attenzione nei contemporanei. Per giungere alle prime considerazioni mediche, prive di basi diagnostiche e con approcci casuali, si dovettero attendere i viaggi per mare degli esploratori europei dopo il 1500. Secondo i diari di bordo, la celebre circumnavigazione del globo di Magellano del 1520 si concluse ad esempio con la morte più dell’ 80% dell’equipaggio per questa malattia. Nel 1601 il Capitano della Marina Britannica James Lancaster, al comando di quattro navi in rotta per l’India, fece invece al riguardo un esperimento: ogni giorno somministrò succo di limone ai marinai di una delle navi, che rimasero quasi tutti in buona salute. Al contrario, 110 dei 278 imbarcati sulle altre tre navi morirono di scorbuto a metà viaggio. Nel XVII secolo l’importanza di questo dato per la navigazione inglese e mondiale era immensa, dato che allora lo scorbuto da solo mieteva più vittime della guerra. Eppure la Marina Britannica non condusse più esperimenti simili fino al 1747, quasi un secolo e mezzo dopo, e solo nel 1795 inserì i limoni tra i suoi rifornimenti. La Marina Mercantile aspettò addirittura il 1865. Come si vede, la gravità di un problema e la semplicità della sua soluzione non garantiscono da sole comportamenti razionali.
Tratto da: Gary Gadner, State of the World
Nel corso degli anni venti la psicologia di massa del consumismo aveva preso il sopravvento nella società americana. Le tradizionali virtù americane – la frugalità yankee e lo spirito della frontiera – avevano perso molto del loro fascino. Nel 1929, la Commissione presidenziale sui recenti cambiamenti economici, voluta dal presidente Herbert Hoover, pubblicò un rapporto rivelatore del profondo cambiamento avvenuto nelle persone in meno di un decennio. Il rapporto terminava con una rosea previsione di ciò che attendeva l’America: “Questa ricerca ha dimostrato, in maniera conclusiva, ciò che un tempo veniva considerato teoricamente vero: i desideri sono insaziabili e ogni desiderio soddisfatto apre la strada a un nuovo desiderio. La conclusione è che di fronte a noi si aprono panorami economici sterminati, e che la soddisfazione di nuovi desideri creerà immediatamente desideri sempre nuovi da soddisfare… Attraverso la pubblicità e altre tecniche di promozione possiamo dare una forte spinta all’attivismo e alla produzione: la nostra situazione è fortunata e gode di un momento di inerzia notevole.” Solo pochi mesi dopo il mercato azionario crollava, gettando la nazione e il mondo in una delle più profonde depressioni dell’era moderna… Puntando alla riduzione dei costi e all’aumento della produttività e del profitto, Il mondo delle imprese non era riuscito a capire che il proprio successo era la radice stessa della crisi.
Jerimy Rifkin, La fine del lavoro
Nel suo viaggio inaugurale, rispetto alle 2.223 persone imbarcate, il Titanic era dotato di sole 20 scialuppe di salvataggio, la cui capacità totale era di 1.178 posti (il 53%). La carenza di barche non era dovuta alla mancanza di spazio, perché il Titanic poteva ospitare fino a 64 imbarcazioni e neppure economica, poiché 32 barche in più sarebbero costate 16.000 dollari, un costo insignificante sui 7,5 milioni di dollari di costruzione del transatlantico. Le motivazioni della mancanza di scialuppe derivavano invece dalle norme di sicurezza obsolete e dall’ingombro visivo delle barche poste sul Ponte lance della nave. Rispetto alle norme, le navi mercantili dell’epoca seguivano le indicazioni del Ministero del Commercio Britannico del 1886 e 1894. Queste norme prevedevano la presenza di almeno 16 scialuppe per le navi superiori a 10.000 tonnellate e con oltre 962 persone e non furono mai aggiornate malgrado il forte aumento del tonnellaggio. L’installazione di 20 barche sul Titanic, nave di 46.328 tonnellate (quattro volte tanto), era quindi perfettamente in regola. Rispetto all’ingombro visivo, i dati di inchiesta rilevarono invece che le decisioni finali furono prese dal Presidente e dall’Amministratore Delegato della White Star Line, compagnia armatrice, per i quali il Ponte lance con 64 scialuppe avrebbe creato disordine e compromesso la vista sul mare dal Salone e dal Ponte di passeggiata dei passeggeri di prima classe. Il naufragio avvenne in 2 ore e 40 minuti; rispetto ai 1.178 posti disponibili nelle barche salirono solo 705 persone. Le vittime furono 1.518.
Google, Titanic wikipedia Il Sesto Artigliere
La Malattia del Marinaio
Il Rapporto Hoover
Le Scialuppe di Salvataggio
Gilberto Giaretta
Marzo. Anno Domini
Mariangela Gualtieri, Nove Marzo Duemilaventi
Questo ti voglio dire
ci dovevamo fermare.
Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti
ch’era troppo furioso
il nostro fare. Stare dentro le cose.
Tutti fuori di noi.
Agitare ogni ora – farla fruttare.
Ci dovevamo fermare E poiché questo Aperto le fessure più segrete Adesso siamo a casa. È potente la terra. Viva per davvero. Se la materia oscura fosse questo Una voce imponente, senza parola Guardare di più il cielo, A quella stretta ____________________________________
Pandemia Epiteto di Afrodite. Allude alla virtù, attribuita alla dea, di unire e rendere solidali gli abitanti di un paese.
Moire Cloto, Lachesi e Atropo, divinità greche simboleggianti il destino degli uomini; per Esiodo figlie della notte, per altri di Zeus e altre divinità. Tenebrose e inesorabili filatrici della vita degli uomini: Cloto tiena la conocchia, Lachesi avvolge il filo al fuso, Atropo taglia il filo con le cesoie
Pandora Quando Zeus si sdegnò contro Prometeo, che aveva formato l’uomo e donato a lui il fuoco, diede a Efesto l’ordine di fare una donna. Efesto formò la donna di terra e di acqua, Atena le diede attitudine ai lavori domestici, Afrodite la bellezza, Ermes l’astuzia; onde questa donna, avendo avuto doni da tutti gli dei, fu chiamata Pandora. Per il suo viaggio terreno, tra tutti i doni ricevuti, Pandora aveva avuto da Zeus un vaso contenente tutti i mali, ella lo scoperchiò e tutti i mali uscirono fuori in folla e si sparsero sulla terra. In fondo al vaso rimase sola la Speranza.
Socrate Di fronte al disfattismo prodotto dai Sofisti, egli pose il fondamento di ogni sapere nell’idea universale della conoscenza. La parte più importante del suo insegnamento è nella morale, il cui fondamento sta nel sapere: la virtù è scienza, poiché si commette il male solo per ignoranza, considerata il solo vizio originario. ____________________________________
… Con queste o con altre parole si è già ricordato che tutti i giorni passati sono vigilie e tutti i giorni futuri sono ciò che sarà. Tornare ad essere vigilia, almeno per un’ora, è il desiderio impossibile di ogni ieri che è passato e di ogni oggi che sta passando. Nessun giorno è mai riuscito ad essere vigilia per tutto il tempo che sognava. … Autoritarie, paralizzanti, circolari, a volte ellittiche, le frasi ad effetto, dette anche maliziosamente briciole d’oro, sono una piaga maligna, tra le peggiori che hanno infestato il mondo. Diciamo ai confusi: conosci te stesso, come se conoscere se stessi non fosse la quinta e la più difficile operazione delle aritmetiche umane. Diciamo agli indecisi: comincia dal principio, come se quel principio fosse il capo sempre visibile di un filo male arrotolato che bastasse tirare e continuare a tirare per giungere all’altro capo, quello della fine. … Fortunatamente ci sono i libri. Possiamo dimenticarli su uno scaffale o in un baule, lasciarli in preda alla polvere e ai tarli, abbandonarli nel buio delle cantine, possiamo non posarvi lo sguardo sopra né toccarli per anni e anni, ma a loro non importa, aspettano tranquillamente, chiusi su sé stessi perché nulla di ciò che contengono si perda, il momento che arriva sempre, quel giorno in cui ci domandiamo, Dove sarà quel libro che insegna a cuocere la creta, e il libro, finalmente convocato, compare, è qui tra le mani… ____________________________________
“La nostra comprensione nasce dalla capacità di gestire. Ciò che non siamo in grado di gestire ci è «ignoto»; e l’«ignoto» fa paura. La paura è un altro nome che diamo al nostro essere senza difese.“
“Oggi, il modo con cui guadagniamo i mezzi per vivere, i valori della professionalità, la valutazione che la società dà alle virtù e ai successi, i legami intimi e i diritti acquisiti, tutto questo è fragile, provvisorio e soggetto alla revoca. E nessuno sa quando e da dove arriverà il colpo fatale, mentre i nostri antenati sapevano bene che occorreva avere paura di lupi affamati o dei banditi sui cigli delle strade. Non è quindi l’astrazione a rendere i pericoli in apparenza più gravi, ma la difficoltà di collocarli, e quindi di evitarli e di controbatterli.“
“L’unico modo davvero promettente di iniziare una terapia contro la crescente paura che finisce per renderci invalidi è reciderne le radici e l’unico modo davvero promettente di continuare questa terapia richiede che si affronti il compito di recidere quelle radici. Il secolo che viene può essere un’epoca di catastrofe definitiva o un’epoca in cui si stringerà e si darà vita a un nuovo patto tra intellettuali e popolo, inteso ormai come umanità. Speriamo di poter ancora scegliere tra questi due futuri.“
“L’estensione della responsabilità di cui «La società del rischio» ha bisogno e di cui non può fare a meno se non al costo di esiti catastrofici, non può essere argomentata o favorita nei termini che sono più comuni e approvati nel nostro tipo di società: quelli dello scambio e della reciprocità dei benefici. Qualunque altra cosa si vuole che sia la morale cercata, dev’essere prima di tutto un’etica dell’autolimitazione.“ ____________________________________
Dopo la pioggia viene il sereno ____________________________________
… E alla terra che dorme, attraverso il mio labbro, tu sia la voce di una profezia. O vento, se viene l’inverno, potrà la primavera essere lontana?
e non ci riuscivamo.
Andava fatto insieme.
Rallentare la corsa.
Ma non ci riuscivamo.
Non c’era sforzo umano
che ci potesse bloccare.
era desiderio tacito comune
come un inconscio volere –
forse la specie nostra ha ubbidito,
slacciato le catene
che tengono blindato
il nostro seme.
e fatto entrare.
Forse per questo dopo c’è stato un salto
di specie – dal pipistrello a noi.
Qualcosa in noi ha voluto spalancare.
Forse, non so.
È portentoso quello che succede.
E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.
Forse ci sono doni.
Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.
C’è un molto forte richiamo
della specie ora e come specie adesso
deve pensarsi ognuno. Un comune destino
ci tiene qui. Lo sapevamo. Ma non troppo bene.
O tutti quanti o nessuno.
Io la sento pensante d’un pensiero
che noi non conosciamo.
E quello che succede? Consideriamo
se non sia lei che muove.
Se la legge che tiene ben guidato
l’universo intero, se quanto accade mi chiedo
non sia piena espressione di quella legge
che governa anche noi – proprio come
ogni stella – ogni particella di cosmo.
tenersi insieme di tutto in un ardore
di vita, con la spazzina morte che viene
a equilibrare ogni specie.
Tenerla dentro la misura sua,
al posto suo, guidata.
Non siamo noi
che abbiamo fatto il cielo.
ci dice ora di stare a casa, come bambini
che l’hanno fatta grossa, senza sapere cosa,
e non avranno baci, non saranno abbracciati.
Ognuno dentro una frenata
che ci riporta indietro, forse nelle lentezze
delle antiche antenate, delle madri.
tingere d’ocra un morto. Fare per la prima volta
il pane. Guardare bene una faccia. Cantare
piano piano perché un bambino dorma.
Per la prima volta stringere con la mano un’altra mano
sentire forte l’intesa. Che siamo insieme.
Un organismo solo. Tutta la specie
la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo.
di un palmo col palmo di qualcuno
a quel semplice atto che ci è interdetto ora –
noi torneremo con una comprensione dilatata.
Saremo qui, più attenti credo. Più delicata
la nostra mano starà dentro il fare della vita.
Adesso lo sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro.
Decio Cinti, Dizionario Mitologico
Josè Saramago, La Caverna
Zygmut Bauman, L’arte della vita; Le sfide dell’etica; Cose che abbiamo in comune
Gianni Rodari, Dopo La Pioggia
brilla in cielo l’arcobaleno.
E’ come un ponte imbandierato
e il sole ci passa festeggiato.
E’ bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede, questo è male
soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta,
questa si che sarebbe una festa.
Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.Percy Bysshe Shelley, Ode Al Vento Occidentale
01 Archeologia, Architettura e Arte
Giovanna Rotondi Terminiello
La pala della Natività nella Chiesa di San Siro
In giorni nei quali siamo costretti a vivere il periodo di preparazione al Natale in modo nuovo, polarizzare l’attenzione su una pala d’altare raffigurante la Natività (fig. 1) può essere fonte di appagamento visivo e mentale trattandosi di un soggetto di attualità e di un bel dipinto noto a pochi ma di notevole rilevanza, dal punto di vista tanto artistico quanto storico, nel panorama del rinnovamento avvenuto a Genova nel campo della pittura, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, grazie alla presenza in città di artisti “forestieri”.
La grande tela orna all’interno della basilica di San Siro, nella via omonima, l’altare della cappella Lomellini (fig. 2) ubicata a sinistra del transetto. Il suo autore è Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio. Un nome pressoché sconosciuto ai non addetti ai lavori da cui una domanda: chi era e da dove veniva questo pittore?
Scopriamolo insieme.
Siamo nell’anno 1606: dal 3 al 6 agosto sosta nella nostra città una comitiva di personaggi che, al seguito del marchese Vincenzo Giustiniani, sta per concludere un viaggio iniziato il 1° aprile ad Ancona e conclusosi il 14 agosto a Roma. Il viaggio era stato impegnativo per distanza e durata. Attraversate lungo il versante adriatico le regioni a nord delle Marche, toccata Venezia, superate le Alpi e percorsa da ponente a levante l’Europa centrale, il gruppo aveva raggiunto la meta prefissata, Londra.
Per il ritorno, dopo una breve sosta a Parigi era stata scelta la via del mare con imbarco dalla Francia meridionale: un itinerario di navigazione alto tirrenica con breve tappa a Genova -che del Giustiniani era città di origine (era suo il palazzo allora abitato dalla suocera che, insieme alla piazza su cui affaccia, ancora oggi porta il nome della famiglia)- e conclusione a Roma, sua città di residenza nella prestigiosa magione di via della Dogana Vecchia ove, dopo l’unità d’Italia, troveranno ospitalità gli uffici del Senato.
Della comitiva faceva parte in qualità di ospite proprio il Pomarancio, conoscenza recente -trasformatasi subito in amicizia- del marchese che, come prima sosta di viaggio, era andato in pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto e qui si era incontrato con il pittore intento a decorare ad affresco la Nuova Sala del Tesoro grazie a una committenza derivatagli dagli esiti consolidati di una formazione di matrice fiorentino-romana (il lavoro gli era stato affidato in gara con Caravaggio e Guido Reni). Della comitiva faceva parte anche Bernardo Bizoni, amico personale del Giustiniani, che compilò una relazione del viaggio in forma di diario dalla quale conosciamo tutti i particolari dell’avventura a cominciare dal fatto che per seguire il marchese -dopo un invito accettato con qualche titubanza- il Roncalli sospese a Loreto i lavori di decoro pittorico con disappunto della committenza.
Fu proprio durante il brevissimo soggiorno a Genova che Cristoforo Roncalli dovette ricevere da Giacomo Lomellini, sicuramente conosciuto attraverso Vincenzo Giustiniani, l’incarico di dipingere la Natività per ornare con essa la cappella di famiglia edificata in San Siro quale sepolcro gentilizio tra il 1597 e il 1598 -come da lapide dedicatoria- per volontà di Tommaso e Camilla Lomellini. Nell’affidamento del lavoro, materialmente eseguito dal pittore dopo il rientro a Loreto, non va sottovalutato il peso che dovette avere la figura del Giustiniani, cioè del collezionista ed intenditore d’arte più esperto del tempo la cui intermediazione non poteva che rassicurare il Lomellini sull’esito di un incarico a cui egli teneva in modo particolare per ragioni di prestigio.
Nell’opera di costruzione e arredo del manufatto architettonico la pala d’altare era l’ultimo tassello rimasto di un’operazione per il resto già quasi del tutto compiuta (come testimoniano le fonti documentarie).
Per quanto riguarda l’assetto architettonico ed ornamentale la cappella, munita di cupola ovale e illuminata da un finestrone centinato coperto in parte dal coronamento dell’altare, possiede ricchissimi decori marmorei policromi simmetricamente disposti. La mensa, sorretta da due angeli in marmo bianco scolpiti da Giuseppe Carlone -il quale creò qui una struttura portante di straordinaria eleganza che, per la sua originalità, ebbe tale fortuna da diventare fonte di ispirazione per altri altari- è impreziosita da un paliotto incrostato con ametiste, corniole, diaspro rosso e lapislazzuli ed ornato al centro da una croce di agata orientale realizzata con una pietra di pirite infissa su una pietra grezza simboleggiante il monte Calvario. Altrettanto ricco di intarsi marmorei è il gradino dell’altare mentre le basi e i capitelli delle due colonne laterali sono in bronzo ad ulteriore testimonianza della cura con cui i materiali vennero scelti per arricchire cromaticamente l’insieme e trasformare la cappella nella più “vaga” e “ricca” della chiesa.
Che il Pomarancio conoscesse il contesto d’inserimento del dipinto commissionatogli dal Lomellini è dimostrato dall’impostazione luministico-spaziale che caratterizza la scena della Natività, riecheggiante in chiave correggesca suggestioni sicuramente stimolate in lui anche da opere viste “da turista” durante i tre giorni di permanenza a Genova, come i “notturni” di Luca Cambiaso (pure Vincenzo Giustiniani ne possedeva uno, il Cristo davanti a Caifa, oggi nel museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti) e, per quanto riguarda il rapporto tra terra e cielo (cioè tra reale e soprannaturale), la Circoncisione di Rubens esposta da pochi mesi sopra l’altare maggiore della chiesa del Gesù.
Nella Natività di San Siro, fulcro della composizione è l’immagine del Bambino, il quale emana una luce divina che accarezza la Madonna, san Giuseppe e i pastori facendoli emergere dal buio delle tenebre terrene. Ad essa corrisponde in alto, oltre un diaframma di nubi, una seconda fonte luminosa che accende le vesti degli angeli e si incunea nella cortina nuvolosa, come un faro teatrale, a demarcare sul fondo la scena dell’Annuncio ai pastori. Questa luce trae origine da una sorgente soprannaturale posta al di sopra dei limiti fisici della tela, che trova corrispondenza nella luce reale irradiata nella cappella attraverso il finestrone centinato: così quest’ultimo entra indirettamente a far parte del gioco luministico e compositivo del dipinto insieme al coronamento scultoreo dell’altare i cui angeli, in controluce, svolgono nei confronti dell’adorazione del Bambino la stessa funzione assolta dagli angeli e cherubini dipinti e dai due angeli reggi mensa scolpiti: quella cioè di circondare di presenze celesti la scena della Natività, sottolineando la dimensione ultraterrena dell’evento e rendendone fantasticamente coinvolgente la visione. Nello stesso tempo le tre sorgenti luminose, due immaginarie e una reale, danno vita a suggestivi effetti di controluce, creano un’atmosfera intimisticamente raccolta e valorizzano gli accostamenti cromatici sulla scia espressiva di un gusto tardo manieristico già consolidato a Genova dalla precedente presenza di altri artisti provenienti dalla Toscana -come Benedetto Brandimarte, Pietro Sorri, Aurelio Lomi- e di un’importante pala d’altare di Federico Barocci giunta da Urbino nel 1596 ad ornamento della cappella Senarega in Duomo.
Giovanna Rotondi Terminiello
P.S. Ora al lettore il compito di andare a San Siro per un incontro ravvicinato con questa Natività ancora posta nel contesto iniziale e quindi godibile in tutto il fascino originario.
Giovanna Rotondi Terminiello
Un incontro
Quella che racconto è una storia vera alimentata in me da una serie di ricordi personali risalenti agli anni di lavoro presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria e dal 1996, dopo il pensionamento, ai decenni successivi.
Dalla memoria i ricordi affiorano dando vita, nella mia mente, ad una sorta di immaginaria rappresentazione teatrale articolata in tre atti e scena finale, autonomi l’uno dall’altro per luogo, tempo e azione. Il filo conduttore ideale dell’intera vicenda è in ogni caso lo stesso, cioè un incondizionato amore per l’Arte alla quale protagonisti e comparse si dedicano a tempo pieno con un’attività di natura per alcuni operativa (restauratori, storici dell’arte, addetti alla tutela e alla conservazione dei beni culturali…), per altri creativa.
Un impensato incontro, nel luogo giusto (l’ex Oratorio dell’Immacolata Concezione) e nel momento giusto, tra il personaggio principale della storia (Franca Carbone) e un artista venuto da lontano (Selim) conclude il racconto allacciandone i fili ed offrendo a me il piacere di testimoniarne la genesi – forse sono l’unica a poterlo fare conoscendo totalmente, della vicenda, protagonisti, luoghi e antefatti – con una narrazione (supportata da un corollario di informazioni supplementari) che, in coerenza con quanto detto all’inizio, ho deciso di strutturare in forma di canovaccio teatrale con ambientazioni sceniche rispondenti alla realtà dei luoghi ove la storia è nata e si è svolta.
Atto primo
P r o l o g o
Siamo all’inizio del 1974. E’ viva a Genova, nella galassia dei beni culturali, l’esigenza di poter formare in loco su basi metodologiche e scientifiche, creando in città una scuola apposita, gli operatori tecnici da impegnare nel campo del restauro. La recente presa di coscienza, dovuta ai preoccupanti risultati dell’indagine della commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dall’on. Franceschini sulle condizioni conservative del patrimonio artistico italiano, aveva infatti determinato l’incremento dei fondi statali per la sua conservazione con conseguente accresciuta necessità di ricorrere, per scarsezza in ambito locale di manodopera specializzata, a restauratori provenienti da altre regioni italiane ospitati, per operare, nel laboratorio della soprintendenza a palazzo reale. La necessità era aggravata dal fatto che, al di là dei finanziamenti dello Stato, le generali condizioni di precarietà conservativa del patrimonio culturale della regione avevano moltiplicato le iniziative d’intervento da parte degli enti locali e dei privati.
I tempi di attuazione del progetto, circoscritto inizialmente al solo restauro dei dipinti su tela, maturano nel giro di pochi mesi anche grazie alle sinergie culturali ed operative esistenti tra coloro che allora operavano in città all’interno delle istituzioni interessate: la Regione Liguria (Assessorato alla Cultura), che si impegna a finanziare integralmente la nuova scuola articolata secondo un percorso formativo triennale; l’Accademia Ligustica di Belle Arti, che offre la sede nel palazzo di piazza De Ferrari accollandosi anche gli oneri di carattere gestionale-organizzativo e, in parte, di docenza; l’Università degli Studi di Genova -Facoltà di Lettere (Istituto di Storia dell’Arte) e Facoltà di Scienze (Istituti di Chimica, Fisica e Biologia)- per l’insegnamento delle discipline di rispettiva competenza nell’ottica di studio, preliminare ad ogni processo di cura, della storia, delle tecniche esecutive e delle cause di degrado delle opere su cui operare. Infine, a garantire la scientificità del corso collabora, da Roma, l’Istituto Centrale del Restauro diretto allora da Giovanni Urbani mentre la Soprintendenza ligure sorveglia e dirige gli interventi conservativi compiuti dagli allievi sotto la guida dei maestri e degli assistenti restauratori, impegnati didatticamente a tempo pieno.
La scuola apre i battenti nell’autunno del 1974.
S c e n a
Aula-laboratorio ubicata al primo piano del palazzo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.
I giovani allievi del primo anno del corso, iniziato da pochi mesi, sono intenti ad esaminare alcune tele distese sui tavoli da lavoro o esposte su cavalletti: in primo piano Franca Carbone e Nino Silvestri; gli altri (Patrizia Magliano, Elena Bolognesi, Laura Tacelli, Cristina Bonavera, Graziella Perazzolo, Carla Campomenoso, Flavio Brunetti…) più indietro, divisi in gruppi. I dipinti, in maggioranza sette-ottocenteschi, provengono dai depositi della quadreria dell’Accademia (ancora chiusa al pubblico dopo la parentesi bellica), sono variamente segnati dal degrado conservativo e fanno tutti parte di una serie di opere ritenute dal corpo docente didatticamente idonee ai fini dell’apprendimento delle tecniche restaurative. Si riconoscono, appese alle pareti, alcune delle tele destinate a diventare oggetto di cura da parte degli apprendisti restauratori nel corso del triennio 1974-1977: tra esse Il bacio di Giove di Pietro Costa; La negazione di Pietro di Angelo Giacinto Banchero; Il sacrificio di Ifigenia di Alessandro Canepa; alcuni Ritratti di pittori liguri di Carlo Giuseppe Ratti, Amore e Psiche di Rosa Carrea Bacigalupo; S. Maria Maddalena in meditazione di Santo Tagliafichi; il Ritratto della sorella Anna di Giovanni Battista Monti; La parata militare alle cascine di Luigi Garibbo; il Ritratto dell’incisore Francesco Granara di Francesco Gandolfi…
Calcano la scena in ordine sparso, oltre agli allievi, i docenti delle varie materie curricolari (gli storici dell’arte Ezia Gavazza e Franco Sborgi, i chimici Giuseppe Guanti e Gilda Zanicchi, il fisico Carlo Pontiggia, i restauratori Alessandro Arrigoni e Luisa Muller, gli assistenti restauratori Emilia Santona e Paola Bruzzo) e i referenti a livello apicale della Soprintendenza (la scrivente), dell’Accademia Ligustica di Belle Arti (Gianfranco Bruno) e della Regione Liguria (Piera Rum).
Questa riunione collegiale rispecchia la realtà degli incontri periodici tra docenti e allievi finalizzati alla verifica delle operazioni di restauro già effettuate, allo scambio delle informazioni acquisite attraverso la ricerca (analisi di laboratorio e storico-critiche), alla definizione delle procedure da adottare nel prosieguo dei lavori.
Le finestre dell’aula orientate su De Ferrari filtrano il forte rumore del traffico cittadino, allora ampiamente concentrato in quella piazza: un rumore a cui si contrappone il silenzio delle rovine del teatro Carlo Felice, ancora semidistrutto dalla guerra e in stato di abbandono, visibili in tutta la loro imponente estensione dagli affacci dell’aula sullo slargo dedicato oggi a Sandro Pertini.
Atto secondo
P r o l o g o
Ubicato in salita Castelletto, nel tratto iniziale di raccordo con piazza della Meridiana, svetta come quinta scenica di fondo, in corrispondenza di un’ampia curva -la prima di quello scosceso percorso pedonale-, un palazzo di fondazione ottocentesca (nel 1875 già esisteva, come da testimonianza dell’Alizeri), detto “casa Montanaro” dal cognome della famiglia che, possedendolo, fu anche destinataria, nel 1912, del decreto di vincolo monumentale emesso dallo Stato.
L’edificio sembra più alto dei sei piani da cui è composto per la visione ribassata imposta dalla pendenza del terreno. Il suo prospetto è bugnato in corrispondenza dei due piani bassi, possiede un portale marmoreo e, sulla destra, è caratterizzato dalla presenza di una grande arcata di collegamento pubblico a via della Concezione dalla quale si accede all’immobile immediatamente retrostante, sede della scuola elementare Daneo. La struttura di casa Montanaro è dignitosamente compatta ma priva, nella veste esteriore, di elementi tali da far presagire l’esistenza, all’interno, di una quantità di tesori d’ importanza eccezionale per la storia di Genova. I quali, quindi, sono ignoti ai più e questo anche perché l’immobile è da sempre di proprietà privata con le conseguenti difficoltà d’ingresso (reso possibile solo da pochi mesi, ma in giorni prestabiliti e limitatamente allo scalone d’ingresso e all’atrio). Fa eccezione, dalla visione esterna, la presenza in facciata di una lapide moderna che ricorda “l’illuminante esperienza della nuit de Genes” vissuta da Paul Valery il 5 ottobre 1892 quando venne ospitato da parenti genovesi in un appartamento del quarto piano (ancora esistente nel suo assetto ottocentesco).
Palazzo Montanaro sorge in corrispondenza del terreno di fondazione del primo chiostro del convento di San Francesco di Castelletto di cui conserva, adibita ad atrio, gran parte della galleria ovest. Altri resti della chiesa e del convento connotano le realtà architettoniche ed ambientali vicine: la scuola Daneo (nelle cui strutture è inglobata tutta la galleria nord sempre del primo chiostro) e, con una discontinuità di visione imposta dalla frammentarietà dei reperti, il giardino ubicato a monte dei palazzi Bianco e Tursi e l’apparato murario dell’edificio comunale affacciato su quello spazio verde.
S c e n a
Atrio della casa Montanaro (salita San Francesco n.7) con visione, sul fondo, della parete trecentesca e, di scorcio, delle volte gotiche a crociera già appartenute alla galleria ovest del secondo chiostro. Più in avanti si intravvedono sempre di scorcio, di fattura ottocentesca, il parapetto, il pavimento marmoreo e gli ultimi gradini dello scalone che collega il portone d’ingresso con l’atrio, posto ad una quota superiore per il forte dislivello del suolo.
Siamo nell’autunno del 1986. Nella fase di studio finalizzato alla preparazione della mostra “Giovanni Pisano a Genova” (un’esposizione realizzata nell’anno successivo: dalla chiesa di San Francesco di Castelletto provengono i frammenti del monumento funebre di Margherita di Brabante scolpito da Giovanni Pisano nel 1313) alcuni funzionari delle Soprintendenze liguri, tra cui Giorgio Rossini e la scrivente, stanno eseguendo un sopralluogo alla presenza dei proprietari avvalendosi a fini conoscitivi anche delle notizie tratte dalla documentazione di supporto alla visita e cioè i decreti di vincolo e le descrizioni sette-ottocentesche di San Francesco di Castelletto pubblicate nelle guide del Ratti e dell’Alizeri. La sorpresa dei funzionari è grande quando, spalancati i battenti del portone ubicato al centro della parete trecentesca -ricca di epigrafi, sculture e elementi strutturali e decorativi in marmo e ardesia correlati alla storia del convento- si spalanca davanti ai loro occhi una cappella-oratorio in stato di semi-abbandono (l’ambiente è invaso dalle ragnatele e adibito a magazzino ), decorata con stucchi e arredi tardo barocchi che la decontestualizzano, per stile e datazione, dalla realtà architettonica confinante (a parte il pavimento originale in ardesia con tozzetti in marmo bianco che costituisce unico elemento di continuità cromatica con la parete trecentesca dell’atrio). Il sorprendente ed inaspettato ritrovamento stimola i presenti ad un confronto supportato dall’osservazione visiva, dalla lettura delle epigrafi poste ai lati del portale d’ingresso e dalle poche notizie immediatamente acquisite consultando la Guida di Genova dell’Alizeri (che parla della cappella solo nell’edizione del 1875) laddove si legge, a proposito della distruzione del complesso francescano, che “allo sperpero di cotanto edificio sopravvisse, per caso assai strano, un modesto oratorio intitolato alla Immacolata Concezione, ricinto e sto per dir chiuso in moderna fabbrica…con l’arco acuto che segna l’ingresso. Fa parte del chiostro di S. Francesco, e ricetto a devota Consorzia di laici; e se punto giovasse, potrei far parola di più lavori da loro commessi ad egregi maestri…” ).
In seguito, con la progressione degli studi dovuta in massima parte all’impegno di Giorgio Rossini, si scoprirà che quell’ambiente, fin dalle origini d’impianto planimetrico quadrangolare con abside quadrata, fu strutturato da Megollo Lercari alla fine del Trecento ed utilizzato come seconda sala capitolare del convento fino alla metà del XVI secolo. Nel 1582 un discendente di Megollo, Franco Lercari q. Nicolò, finanziò il rifacimento della volta di copertura, bisognosa di manutenzione.
Le notizie note sulle origini della cappella sono queste: è ancora sconosciuta la data della sua trasformazione in oratorio dedicato all’Immacolata Concezione -previa apertura delle finestre in facciata e sul retro, decorazione a stucco dorato delle pareti e nuovo arredo- e chi promosse tali lavori, a parte la notizia che nei suoi spazi furono unitariamente attive, dal 1806, le confraternite di Castelletto e di S. Ugo (trasferita qui, quest’ultima, dalla chiesa inferiore della commenda di Prè da cui proviene anche il quadro di Stefano Magnasco con S. Ugo che fa scaturire l’acqua da un sasso: l’ingrandimento in altezza e la forma perimetrale a compasso mistilineo della tela dipendono infatti dalla necessità d’inserirla, nella nuova sede, entro la cornice a stucco dell’altare di sinistra). E’ sconosciuta anche la data di estinzione delle due confraternite con il conseguente abbandono di uno spazio diventato ormai inutile.
Atto terzo
P r o l o g o
Negli anni successivi agli avvenimenti ricordati nel primo atto gli apprendisti restauratori, acquisito il diploma dopo i tre anni di corso, iniziano ad operare uniti in cooperativa (molte tele del Museo dell’Accademia Ligustica risultano restaurate da loro) per poi dividersi, due anni dopo, e cominciare a lavorare singolarmente o in piccoli gruppi (alcuni entrano in Regione dando vita ad un laboratorio di restauro ancora oggi attivo). Due dei diplomati migliori, Franca Carbone e Nino Silvestri, fondano il “Laboratorio di restauro di San Donato” e lo fanno crescere grazie a numerose committenze di lavoro, tanto pubbliche quanto private, che ottengono in virtù delle indiscusse capacità professionali affinate da un continuo aggiornamento e dal confronto costruttivo con gli altri addetti ai lavori, primi fra tutti i tecnici della Soprintendenza. L’affidabilità dei due restauratori è così grande che vengono destinati alle loro cure capolavori assoluti come per esempio L’Assunta di Guido Reni della chiesa del Gesù, L’Ultima Cena del Procaccini della chiesa della SS. Annunziata, i tre ritratti di Van Dyck (Geronima Sale Brignole con la figlia Aurelia, Anton Giulio Brignole Sale, Paolina Adorno) della Galleria di Palazzo Rosso.
Nel 2000 i due decidono di lavorare in autonomia di gestione: quindi ognuno cerca una nuova sede operativa per il proprio laboratorio ed hanno entrambi la fortuna di trovare, adatti all’uopo, spazi di valenza monumentale: Silvestri la chiesa dismessa di S. Maria in Via, a Carignano; Carbone l’oratorio dell’Immacolata Concezione in salita S. Francesco -sì, proprio la cappella protagonista del secondo atto, da alcuni anni in vendita- che acquista, ripulisce, restaura ed adegua alle nuove funzioni restituendole la dignità perduta.
S c e n a
Oratorio dell’Immacolata Concezione. Nel primo pomeriggio di una giornata di maggio (siamo nel 2018) un gruppo di “Amici dei Musei” sta effettuando una visita al laboratorio di restauro di Franca Carbone, guidata da quest’ultima e da me che scrivo. Con la visita si intende offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere la doppia realtà che quello spazio, sconosciuto ai più dei presenti, conserva e racchiude: da un lato la severa struttura medioevale dell’atrio contrapposta alla frizzante leggerezza barocca dell’oratorio; dall’altro la presenza in quest’ultimo -distesi su un banco di lavoro collocato al centro o disposti, tutt’intorno, su cavalletti- di importanti dipinti su tela o tavola in corso più o meno avanzato di restauro. Il godimento estetico è totale, l’attenzione potenziata dall’interesse acceso dalla scoperta, la concentrazione aiutata dalla sapiente presenza di fonti luminose e dal silenzio del contesto cittadino circostante (un silenzio interrotto a un certo punto solo dal vociare degli alunni che escono dalla scuola Daneo). Sugli scanni già dei confratelli è poggiata, per la consultazione, la documentazione fotografica dei più importanti dipinti qui ricoverati in passato per interventi di restauro rivelatisi fondamentali per la progressione degli studi dovuta agli approfondimenti di conoscenza delle materie pittoriche, delle tecniche esecutive e delle genesi creative: tutto ciò grazie ad una collaborazione che, alla luce delle analisi, ha visto sempre attivi in questo laboratorio, secondo un programma di lavoro fondato sul contributo offerto dalle specifiche competenze, storici dell’arte, chimici, fisici e, in funzione di volta in volta sapientemente operativa, Franca Carbone. Il Polittico della Cervara di Gerard David -esposto a Palazzo Bianco nel 2005, dopo il restauro- costituisce in questo senso esempio emblematico non meno significativo del lungo intervento sul Polittico della Rovere di Vincenzo Foppa e Ludovico Brea (proveniente da Savona) che ha impegnato la Carbone dal 2002 al 2008 con risultati eccezionali anche ai fini della conoscenza di un dipinto modificato nell’assetto strutturale da ripetuti montaggi e smontaggi.
Nel mezzo delle spiegazioni si sente suonare alla porta. Franca Carbone va ad aprire e…
S c e n a f i n a l e
…introduce nell’oratorio un signore sconosciuto a tutti ma non a lei, che infatti non si dimostra affatto meravigliata dell’arrivo, e alla scrivente che invece non nasconde la propria sorpresa di trovarsi di fronte l’amico Selim (questo è il nome dello sconosciuto) in un luogo ove mai si sarebbe immaginata di poterlo incontrare. Selim è un grande scultore (bronzi e terracotte, oltre ad un’attività grafica che spazia dal disegno all’incisione e alle tecniche miste). Nato a Bagdad e diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, risiede nel Canton Ticino con lunghe parentesi abitative e di lavoro a Parigi, ad Atene e in modo sporadico a Genova, da lui molto amata tanto da progettare di vivere ed operare in modo stabile nella nostra città. Di questo chi scrive era a conoscenza, ma non del fatto che la ricerca di una “casa-laboratorio” lo avesse portato a salire al palazzo Montanaro avendo egli appreso, attraverso un mediatore, che uno spazio “interessante” era qui in vendita perché la proprietaria -cioè Franca Carbone– intendeva cederlo (anche questo mi era ignoto) per il giusto riposo dopo quarant’anni di lavoro nel campo della conservazione delle opere d’arte.
In conclusione, l’incontro del tutto casuale tra la restauratrice genovese e l’artista venuto da lontano aveva già determinato, poco prima della visita degli Amici dei Musei, un passaggio di proprietà dell’ex oratorio avvenuto tra i due all’insegna di traguardi operativi analoghi per contenuti (l’Arte al centro della vita) e per iniziative di valenza culturale.
Il racconto della mia amicizia con l’artista Selim (e con sua moglie Irene) non fa parte di questa storia: solo per completezza d’informazione specifico che l’ho conosciuto nel 1999 attraverso Gianfranco Bruno -il direttore dell’Accademia Ligustica, citato nel primo atto: è stato uno dei primi critici del lavoro creativo di Selim- in occasione di una mostra nella Galleria Devoto (ne seguiranno altre, a Genova e in Liguria, in importanti sedi museali come la Commenda di Pré nel 2011 e il Museo Archeologico del Finale nel 2112).
Come esito degli intrecci di vita qui narrati, inizia da oggi una nuova fase storica per l’oratorio dell’Immacolata Concezione ove le creazioni di Selim potranno dialogare, come già analogamente avvenuto nelle mostre appena ricordate, con le testimonianze artistiche dell’antico insediamento francescano di Castelletto.
Giovanna Rotondi Terminiello
Lo stare in casa coatto mi permette di utilizzare il tempo anche per togliermi qualche curiosità. Tra queste, l’identificazione del grande quadro che, nelle conferenze stampa di questi giorni, compare alle spalle del presidente Conte mentre parla (allego un’immagine). Si tratta di una fedele copia cinquecentesca di un affresco di Raffaello nella stanza della Segnatura in Vaticano raffigurante Papa Leone Magno che ferma l’invasione di Roma da parte degli Unni comandati da Attila ( soprannominato “il flagello di Dio”). Sicuramente l’immagine è stata scelta per omaggio a Raffaello ma anche e soprattutto per il significato simbolico che in questo momento assume: Il governo, con le sue severe prescrizioni, come fece allora il papa con Attila, fermerà il flagello del Coronavirus…salvando, insieme all’Italia, tutti noi! Speriamolo davvero!
Abbiamo ricevuto questa domanda da parte di un nostro Associato: ” cosa sono, e se hanno un qualche significato specifico, quelle due stelle a punte che sormontano la struttura lignea che fa da base al quadro?
Carla Costanzi
Vi segnaliamo il link di Finestre sull’Arte, rivista online di Arte antica e contemporanea, iscrivendosi alla newsletter potrete rimanere aggiornati su tutti gli eventi
https://www.finestresullarte.info
02 Letteratura, Cinema, Musica e Teatro
Massimiliano Damerini
Mi ero riproposto di parlarne all’avvio dei nostri incontri, ma può essere una buona idea farlo adesso, soprattutto perché gli appassionati, essendo obbligati a rimanere a casa, possono ascoltare un po’ di buona musica, allontanando per qualche ora eventuali pensieri sgradevoli…
Si tratta di due album: il primo volume dell’integrale delle Sonate di Beethoven (che, se non subentreranno complicazioni, dovrebbe terminare con l’ottava uscita fra un paio di anni), e la registrazione del mio ultimo concerto al Carlo Felice per la GOG dello scorso novembre.
Questo concerto si intitola “Atmosfere viennesi (Wiener Atmosphäre)” perché basato su quattro sonate tutte composte a Vienna.
Ecco i link dove si possono ascoltare e scaricare:
https://fanlink.to/BeethovenCompletePianoSonatas1
https://fanlink.to/WienerAtmosphare
Beethoven, che avrei trattato quest’anno, è presente con 5 Sonate: nel I volume
dell’integrale con le sue prime 4 Sonate, e nel recital della GOG con la Sonata
op.90.
Se tutto va nel verso giusto, a giugno uscirà il II volume, nel quale sarà inserita la Sonata op.13 “Patetica” di cui avrei parlato nella prima lezione.
Un grande abbraccio a tutti gli amici di Uniauser, sarà dura ma ce la faremo!”
03 Storia e Filosofia
Giustina Olgiati
Care amiche, cari amici di Uniauser, mentre il 2020 volge al termine, sentiamo ripetere da ogni parte che questo che sta arrivando sarà il Natale più strano, perché non ci sarà permesso di festeggiarlo con amici e parenti. Bene, non è vero. Nel 1684, l’anno del grande bombardamento di Genova da parte di Luigi XIV, si fece esattamente lo stesso: furono proibite perfino le tradizionali visite di auguri al doge e ai componenti delle varie magistrature, dando disposizione che a questo si attenessero anche i privati.
Figura 1
1684, 13 dicembre
Si delibera che per quest’anno non si ricevano ufficii di buone feste nel prossimo Natale a Palazzo, e che di questa deliberatione se ne dia notizia al Minor Consiglio essortando la cittadinanza a prenderne le loro misure anche rispetto a simili ufficii fra privati et magnifici segretarii, Cancellieri et altri ministri o magistrati si astengano parimente dal passar simili ufficii per quest’anno. Per serenissima Collegia ad calculos.
Mugugni? Assolutamente no, anzi, il contrario! Il provvedimento venne riproposto successivamente e, nel 1688, ne venne richiesta una nuova applicazione con uno dei “biglietti di calice”, i suggerimenti anonimi che venivano lasciati al Governo dai componenti dei Consigli:
Signori serenissimi,
fu da tutta città lodato il decreto fatto da VV.Serenissime di non dar le buone feste l’anno passato, così hora si rappresenta a VV.Serenissime l’ordinare l’istesso, essendo un mero invesendo disturbo ad ogni sorte di persona e mera adulatione e inquietudine di non prepararsi bene a ricevere Nostro Signore ne le feste.
I genovesi – sempre un po’ stundai – preferivano quindi godersi in santa pace le feste natalizie, senza tutto l’invexendo provocati dalla necessità di presentare (o subire) troppe visite di auguri.
Nella Genova antica le feste natalizie erano essenzialmente religiose, estranee al consumismo che le caratterizza oggi. Il governo compiva poche e mirate azioni di carità, mitigando le pene corporali inflitte ai condannati e concedendo ai carcerati della Malapaga, i debitori insolventi, quelle licenze di uscita che spesso rappresentavano occasioni di fuga, contribuendo a ridurre l’affollamento del carcere.
Esisteva già allora il problema delle ferie: nel 1506 a chiederle è addirittura il podestà, Obertino de Soleri, che desidera «andare a casa e rivedere i suoi cari e celebrare con loro la festività del Natale».
Figura 2
Il problema non era cosa da poco, perché il podestà era il magistrato incaricato dell’amministrazione della giustizia e doveva essere uno straniero, di nascita non genovese. La sua assenza sarebbe quindi durata per giorni, in un periodo nel quale reati e delitti non sarebbero certo mancati. Per accordare la licenza richiesta, a titolo straordinario, il Senato decise di nominare come suo luogotenente il giudice del malefici, Giovanni Martino Antina, che avebbe esercitato l’incarico fino al ritorno di Obertino. Un modo creativo di risolvere il problema.
Poiché il nuovo anno – secondo il metodo di computo del tempo noto come Stile della Natività – iniziava il giorno di Natale, il Capodanno, festa della circoncisione di Gesù, non veniva festeggiato come ai nostri giorni. Era invece importante l’Epifania, celebrata soprattutto negli stabilimenti commerciali in Oriente, nei quali i componenti di diverse etnie religiose coesistevano pacificamente grazie alla costante attenzione dei genovesi nell’evitare episodi di intolleranza. I registri della contabilità della colonia di Caffa, in Crimea, ci consentono di ricostruire lo svolgimento della festività nel 1466 attraverso le spese per i donativi in denaro, frutta e bevande a tutti i sacerdoti che prendono parte all’evento: i cinque (presumibilmente greci) che cantano callimera dinanzi al Console e alla sua curia durante la vigilia; i sacerdoti armeni che cantano le Laudi; i sacerdoti greci che la mattina dell’Epifania cantano dinanzi al console sulla piazza del Palazzo. Frutta e bevande vengono offerte anche agli addetti alle campane; ai ragazzi e ai marinai che si tuffano in acqua in occasione della benedizione del mare; ad alcuni sacerdoti saraceni. Tra le spese registrate figura anche quella per l’offerta di 4 ceri per la chiesa di S. Maria del bazar.
Figura 3
Per farvi i miei auguri più cari ho scelto una pergamena “di recupero”, il foglio di un codice del XIV secolo, riutilizzato successivamente per ricoprire il frontalino di una delle filze di documenti dell’Archivio. Il frammento, restaurato attraverso l’iniziativa “Adotta un documento”, proviene da un Antifonario dell’Ufficio e riporta il Secondo Notturno della Notte di Natale. Contiene tre diverse scritture musicali: sul verso è aggiunta in margine l’antifona Orietur in diebus Domini habundantia pacis et dominabitur su tetragramma in neumi lotaringici; sul recto la stessa scrittura non corsiva per l’antifona Liberasti virgam e neumi gotici per l’antifona Esto mihi Domine in Deum protectorem.
Figura 4
Figura 5
La pergamena riporta il testo integrale del Salmo 71 (o 72, secondo altri testi) di Salomone, che canta la gloria del regno di Dio.Personalmente, anche in questo anno così tragico ho molte cose per le quali sento di dover ringraziare l’Onnipotente: se è così anche per voi, vi invito a leggere questo breve testo, con la speranza che sia per tutti noi un augurio di tempi migliori.
O Dio, da’ i tuoi giudizi al re e la tua giustizia al figlio del re;
ed egli giudicherà il tuo popolo con giustizia
e i tuoi poveri con equità!
Portino i monti pace al popolo,
e le colline giustizia!
Egli garantirà il diritto ai miseri del popolo,
salverà i figli del bisognoso,
e annienterà l’oppressore!
Ti temeranno finché duri il sole,
finché duri la luna, di epoca in epoca!
Egli scenderà come pioggia sul prato falciato,
come acquazzone che bagna la terra.
Nei suoi giorni il giusto fiorirà
e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna.
Egli dominerà da un mare all’altro
e dal fiume fino all’estremità della terra.
Davanti a lui s’inchineranno gli abitanti del deserto,
i suoi nemici morderanno la polvere.
I re di Tarsis e delle isole gli pagheranno il tributo,
i re di Seba e di Saba gli offriranno doni;
tutti i re gli si prostreranno davanti,
tutte le nazioni lo serviranno.
Poich’egli libererà il bisognoso che grida
e il misero che non ha chi l’aiuti.
Egli avrà compassione dell’infelice e del bisognoso
e salverà l’anima dei poveri.
Riscatterà le loro anime dall’oppressione e dalla violenza
e il loro sangue sarà prezioso ai suoi occhi.
Egli vivrà; e a lui sarà dato oro di Seba,
la gente pregherà per lui tutto il giorno, lo benedirà sempre.
Vi sarà abbondanza di grano nel paese, sulle cime dei monti.
Ondeggeranno le spighe come fanno gli alberi del Libano
e gli abitanti delle città fioriranno come l’erba della terra.
Il suo nome durerà in eterno,
il suo nome si conserverà quanto il sole;
gli uomini si benediranno a vicenda in lui,
tutte le nazioni lo proclameranno beato.
Sia benedetto Dio, il Signore,
il Dio d’Israele,
egli solo opera prodigi!
Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso
e tutta la terra sia piena della sua gloria!
Amen! Amen!
I miei più cari auguri di un sereno Natale. Giustina Olgiati
Giustina Olgiati
L’Archivio di Stato di Genova presenta il percorso virtuale
Anno del Signore 1458: la peste a Genova
Un breve percorso tra i documenti dell’Archivio di Stato di Genova riporta l’attenzione sulla peste che colpì la città nel 1458, evento tanto diverso dall’attuale emergenza sanitaria da aver con essa davvero poco in comune in termini scientifici e storici, eppure affrontato dai genovesi di allora, come da noi oggi, con timore, dubbio e grande coraggio, nella speranza di un avvenire migliore.
Il percorso è disponibile sul sito web istituzionale alla pagina
http://www.asgenova.beniculturali.it
Giustina Olgiati
L’affresco che Domenico Fiasella realizzò nel 1626 nella parete sopra lo scalone sinistro di Palazzo Ducale simboleggia il pericolo scampato dalla Repubblica di Genova nello scontro con il duca di Savoia nel 1625. Il bozzetto dell’opera è conservato presso l’Archivio di Stato di Genova. In questo momento così particolare, lo abbiamo scelto per rivolgere a tutti voi i nostri auguri più sinceri.
Il Covid-19 ha colpito tutta la società italiana, anche il mondo della cultura. Abbiamo dovuto annullare conferenze, mostre, visite guidate. Non sappiamo quando potremo riaprire l’Archivio e con quali limitazioni. Il nostro pensiero, in particolare, va a tutti gli studiosi, i ricercatori e i restauratori che non possono continuare la loro attività e che non hanno, come noi, il posto fisso. Sono loro a conoscere le maggiori difficoltà, e a loro va il nostro più affettuoso abbraccio.
Andrà tutto bene, restate a casa. Nell’attesa che l’emergenza finisca stiamo lavorando per voi, per parlare di cultura anche attraverso la rete, nell’attesa di tornare a farlo di persona.
L’Archivio di Stato di Genova porge a tutti voi i più cari e sinceri auguri di Buona Pasqua.
1626, gennaio 27, Genova
Domenico Fiasella
Bozzetto dell’affresco di Palazzo Ducale con la Vergine e i Santi Giovanni Battista, Giorgio e Bernardo di Chiaravalle che intercedono presso la Trinità per salvezza della città di Genova
Disegno a matita, penna, acquerello e biacca su carta, mm 533 x 398
AS Ge, Camera della Repubblica, 175, Atti, doc. 165
Giustina Olgiati
Autocertificazioni e salvacondotti
Dopo tutto il parlare che si è fatto sulle autocertificazioni e sulle limitazioni alle libertà personali determinate dall’epidemia di Covid 19, ho ripensato a situazioni analoghe che si sono prodotte nel passato, da quello più remoto al più recente.
In epoca medievale per muoversi da uno Stato all’altro era necessario munirsi di un salvacondotto, che veniva rilasciato dallo Stato ospite e doveva essere sempre portato con sé. Un esempio tratto dall’Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, Litterarum 1786, c. 334r.:
1441, gennaio 18, Genova
Tommaso Campofregoso, doge di Genova, e il Consiglio degli Anziani. Allo scopo di avere grande abbondanza di vettovaglie nella città di Genova, con l’autorità di questa lettera diamo pieno, sicuro e generale salvacondotto di durata e valore per i prossimi 4 mesi a Giovanni Ochino e Antonio Beriame di Nizza e ai frumenti, formaggi, carni salate e ogni altra merce, denaro, cose e beni di proprietà loro e di ciascuno di loro, perché possano venire nella città e nel distretto di Genova, insieme o separatamente, e qui fermarsi, dimorare, abitare, commerciare, e di qui Nel XV secolo il controllo sull’accesso degli stranieri in città era esercitato dall’Officium bulletarum, che rilasciava ai residenti temporanei un documento (bulleta) da portare sempre con sé e da presentare a osti e padroni di casa. Per i contravventori – ospitanti ed ospitati – erano previste pene pecuniarie (da 100 a 1000 lire) e fisiche (da 2 a 10 tratti di corda) a discrezione del doge. I patroni che trasportavano passeggeri dovevano presentarsi con questi dinanzi agli ufficiali di bolletta entro un’ora dall’attracco nel porto di Genova. Nessuno straniero poteva circolare di notte per la città e i sobborghi di Genova, con lume o senza, sotto pena della forca. L’uso della bulleta è testimonato anche in epoca più moderna, insieme con i controlli operati dall’Ufficio di Sanità sull’arrivo di stranieri a Genova. La mia passione per i mercatini, che dura ormai da trent’anni, mi ha portato ad acquistare carte di tutti i generi, a volte senza nemmeno guardarle prima, se chiuse in quei bustoni incellofanati che spesso contraddistinguono lo svuotamento di un cassetto o della scatola dei ricordi di chi ormai non c’è più. A volte riservano solo delusioni, a volte piccoli tesori inaspettati. Guardate questo documento, che reca incollata sul verso la foto di una anziana signora:
Documento n. 1 Comando della Zona Militare di Arquata e Serravalle Scrivia. N. 358 Arquata, 29 maggio 1918 Salvacondotto La sig. Ghigliotti Giovanna, figlia del fu Antonio e della fu Capurro Maria, nata a Genova 31.12.1858, di professione casalinga, residente a Genova, è autorizzata a soggiornare nella zona d’isolamento dei Depositi Inglesi in Arquata e Serravalle Scrivia, perché ivi dimorante. Durata un anno dalla data suddetta. Il presente salvacondotto deve essere presentato ad ogni richiesta della forza pubblica e dei militari di guardia. Il comandante della zona militare di Arquata e Serravalle Scrivia. Questa volta il lasciapassare non è emesso per uno straniero, ma per un cittadino residente. Facendo una semplice ricerca in Internet, si apprende che Arquata Scrivia dal 1917 al 1929 fu scelta come base delle truppe inglesi inviate a combattere sul fronte italiano. Un centinaio di militari, caduti in guerra o morti a causa dell’influenza spagnola, sono sepolti nel British War Cemetery di Arquata, onorato nel 1923 addirittura da una visita dei sovrani d’Inghilterra, Giorgio V e la regina Mary, nonni dell’attuale regina Elisabetta. Potete vedere alcune immagini di questo piccolo cimitero di campagna su: https://it.wikipedia.org/wiki/Arquata_Scrivia_Communal_Cemetery_Extension E’ datato 26 aprile 1945, giorno successivo alla Liberazione, questo lasciapassare con timbro ancora perfettamente leggibile: Documento n. 2 Comando 9.a Brigata Italia Giustizia e Libertà Il signor Torlasco Francesco fu Santo è autorizzato a circolare in città, in provincia e fuori provincia a qualunque ora del giorno e della notte. I gruppi partigiani gli diano aiuto ed assistenza in qualsiasi circostanza. La bicicletta non può essergli presa. Ge. Sampierdarena, 26 aprile 1945. Il comandante della Brigata – Andrea Santandrea. Se ci ripensiamo sulla base di questi esempi, scopriamo che le autocertificazioni di questi giorni, nelle quali siamo noi stessi a dichiarare sotto la nostra responsabilità le motivazioni dei nostri spostamenti, non sono una limitazione ai nostri diritti ma l’espressione delle libertà personali che abbiamo raggiunto e un profondo richiamo al nostro senso civico. Andrà tutto bene, restate a casa. Quando tutto sarà passato riprenderemo la nostra vita e i nostri interessi con entusiasmo e consapevolezza ancora maggiori. Un forte e caro abbraccio. Giustina Olgiati
Giustina Olgiati
Dante e i miseri
E’ un luogo comune dirlo, ma è vero che la vita riserva continue sorprese. Non parlo della situazione attuale, che si può solo definire straordinaria, ma di quello che può capitare ogni giorno, in special modo dopo aver superato la boa dei 50 anni. Ecco che, abituati alle risposte usuali del nostro fisico – e della nostra mente – a sforzi e fatiche, all’improvviso ci accorgiamo di non avere più la resistenza del giorno prima e scopriamo che la cosa non passa, anche se ci concediamo un po’ di riposo. Inizia così la transumanza da un medico all’altro e da un esame a quello successivo, e ci si può ritrovare, come è successo a me alcuni mesi or sono, in quella specie di polmone d’acciaio che è il macchinario della risonanza magnetica.
Non posso dire di averlo trovato spaventoso, forse anche perché ne ero incuriosita. Mi hanno fatto sdraiare supina, imbrigliato la testa in modo da tenerla ferma e infilato delle cuffie alle orecchie per proteggerle dal rumore, poi mi hanno spinto nel tubo. Temevo una crisi di claustrofobia, che però non è venuta, anche perché l’ambiente era illuminato: malgrado il rumore, forte nonostante le cuffie, il vero problema era la noia. Così, senza accorgermene, ho cominciato a recitare nella mia mente alcuni versi di Dante.
«Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore; fecemi la divina podestate, la somma sapïenza e ‘l primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non etterne, e io etterno duro. Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate».
Non era esattamente quello che serviva a darmi conforto in quella situazione, ma il mare della memoria, un po’ disordinato, ha cominciato a saltellare qua è là tra i miei ricordi scolastici. «Era già l’ora che volge il disio e che lo novo peregrin d’amore * «ricorditi di me, che son la Pia: * «biondo era e bello e di gentile aspetto, … Orribil furon li peccati miei; * «Non impedir lo suo fatale andare: * «La gloria di colui che tutto move * «O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;
In mezzo a questo zibaldone, che avrebbe fatto inorridire la mia professoressa del liceo Doria (la terribile Velleda Cesari), arrivò all’improvviso il canto di Ulisse: «Lo maggior corno de la fiamma antica indi la cima qua e là menando, mi diparti’ da Circe, che sottrasse né dolcezza di figlio, né la pieta vincer potero dentro a me l’ardore ma misi me per l’alto mare aperto Ammetto che su qualche verso ero piuttosto incerta, mentre altri filavano via più lisci: «Io e ‘ compagni eravam vecchi e tardi acciò che l’uom più oltre non si metta; “O frati”, dissi, “che per cento milia d’i nostri sensi ch’è del rimanente Considerate la vostra semenza: Li miei compagni fec’ io sì aguti, e volta nostra poppa nel mattino, Adoro quest’ultima terzina, al punto che non riesco a ripensare ai fratelli Vivaldi e al loro tentativo di aprire una nuova rotta (nel 1291!) senza collegarlo al “folle volo” di Ulisse. La memoria mi ha tradito nelle strofe seguenti, ma non nel finale: «quando n’apparve una montagna, bruna Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; Tre volte il fé girar con tutte l’acque; infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso». L’immagine dei naufraghi mi ha riportato alla mente il tema de i sommersi e i salvati e dello straordinario brano di Se questo è un uomo in cui Primo Levi, durante una marcia faticosa, recita al compagno, che parla un’altra lingua, proprio i versi del canto di Ulisse, che lo aiutano a riappropriarsi della sua più profonda natura umana, nonostante la vita disumanizzante del lager.
Sono corsa a rileggerlo, appena tornata a casa. Voi potete scaricarlo, con il bel commento che lo accompagna, da https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/dante-primo-levi.pdf
Dopo quel giorno ho ritrovato Dante in altre letture, ancora come strumento di conforto nelle avversità più diverse. L’esperienza del carcere, ne Le mie prigioni di Silvio Pellico:
CAPO VI Quando non fui più martirato dagl’interrogatorii, e non ebbi più nulla che occupasse le mie giornate, allora sentii amaramente il peso della solitudine. Ben mi si permise ch’io avessi una Bibbia ed il Dante; ben fu messa a mia disposizione dal custode la sua biblioteca, consistente in alcuni romanzi di Scuderi, del Piazzi, e peggio; ma il mio spirito era troppo agitato, da potersi applicare a qualsiasi lettura. Imparava ogni giorno un canto di Dante a memoria, e questo esercizio era tuttavia sì macchinale, ch’io lo faceva pensando meno a que’ versi che a’ casi miei. Lo stesso mi avveniva leggendo altre cose, eccettuato alcune volte qualche passo della Bibbia. Questo divino libro ch’io aveva sempre amato molto, anche quando pareami d’essere incredulo, veniva ora da me studiato con più rispetto che mai. Se non che, ad onta del buon volere, spessissimo io lo leggea colla mente ad altro, e non capiva. A poco a poco divenni capace di meditarvi più fortemente, e di sempre meglio gustarlo.
CAPO LXXX I cresciuti rigori rendevano sempre più monotona la nostra vita. Tutto il 1824, tutto il 25, tutto il 26, tutto il 27, in che si passarono per noi? Ci fu tolto quell’uso de’ nostri libri che per interim ci era stato conceduto dal governatore. Il carcere divenneci una vera tomba, nella quale neppure la tranquillità della tomba c’era lasciata. Ogni mese veniva, in giorno indeterminato, a farvi una diligente perquisizione il direttore di polizia, accompagnato d’un luogotenente e di guardie. Ci spogliavano nudi, esaminavano tutte le cuciture de’ vestiti, nel dubbio che vi si tenesse celata qualche carta o altro, si scucivano i pagliericci per frugarvi dentro. Benché nulla di clandestino potessero trovarci, questa visita ostile e di sorpresa, ripetuta senza fine, aveva non so che, che m’irritava, e che ogni volta metteami la febbre. Gli anni precedenti m’erano sembrati sì infelici, ed ora io pensava ad essi con desiderio, come ad un tempo di care dolcezze. Dov’erano le ore ch’io m’ingolfava nello studio della Bibbia, o d’Omero? A forza di leggere Omero nel testo, quella poca cognizione di greco ch’io aveva si era aumentata, ed erami appassionato per quella lingua. Quanto incresceami di non poterne continuare lo studio! Dante, Petrarca, Shakespeare, Byron, Walter Scott, Schiller, Goethe, ecc., quanti amici m’erano involati!
Anche la breve vita del genovese Angelo Campodonico (21 ottobre 1895 – 25 aprile 1917), caduto sul Carso durante la Prima Guerra Mondiale, è stata accompagnata da Dante fino alla sua fine sul campo di battaglia:
30 gennaio 1917 Cari genitori, vorrei ringraziarvi degli innumerevoli doni che mi avete mandato, come la scattola di dolci ecc. Ringrazio in particolar modo mia sorella del porta tovagliolo che mi ha mandato e della piccola Divina Commedia che è così cara al mio spirito. Dono più gradito non mi poteva pervenire, gradito come la donatrice.
Così ricorda la sorella Annina nel libro Lauri di gloria. Epistolario d’un eroe. Lettere del tenente Angelo Campodonico. A cura di Mario Panizzardi. Genova, 1918, che potete scaricare dal sito: http://www.internetculturale.it/jmms/objdownload?id=oai%3Abncf.firenze.sbn.it%3A21%3AFI0098%3AEUROPEANA_a0537%3AIEI0140918&teca=Bncf&resource=img&mode=all :
Il suo orologio andava ancora, quando il Cappellano lo trovò morto, e glielo tolse dal polso. In un taschino sul petto rinvenne una “Divina Commedia” minuscola, che io gli avevo regalato a Natale: la portava sempre con sé. Nella trincea, nei primi tempi di guerra, la sera, egli ed un suo compagno, infilati nel sacco-letto, prima di coricarsi leggevano, mio fratello un canto di Dante ed il compagno un brano dei “Promessi sposi”, al lume della candela.
Tra le cose sue trovammo un’altra copia della “Divina Commedia”, sgualcita, vecchia, rilegata in rosso. Aveva le pagine macchiate di terra e di chiazze rossastre, perché l’anilina, dal margine dei fogli, nei giorni di pioggia, era colata nell’interno: segno evidente che gli era stata sempre compagna.
Nello stesso testo, anche il commilitone Ernesto Lufino ricorda la passione comune per la Commedia:
(…) non ho bisogno delle fotografie, per ricordarlo all’evidenza: mi basta rivolgere il pensiero a lui per vederlo e sentirne la voce: sentirne la voce ben modulata, armoniosa, delle felici ore nelle quali, indifferenti a’ pericoli e disagi, ci riunivamo lui, io e Giovanni Di Bollo, da Sulmona, a leggere Dante o a declamare Carducci. Era il nostro divertimento favorito. Leggevamo uno, due, tre canti per turno; ma il più delle volte era lui che pregavo di leggere, per sentire gli immortali versi danteschi scanditi dalla sua voce chiara, con quella lieve cantilena che era sua propria (e forse la traeva dal suo dialetto), e che accompagnava i divini ritmi con una dolce vaghezza di risonanze, che parevan echi di lontane voci corali. In tutta la marcia di trasferimento dal Carso al Trentino, non facemmo altre che leggere Dante. Ad ogni alt un po’ lungo, ad ogni fermata nei paesetti del Veneto, ci riunivamo; spesso l’uditorio si faceva più numeroso. Ogni luogo era buono: un mucchio di sassi lungo la strada, o la sponda di un fosso, un prato verde di alte erbe o una tenda.
Dopo il terribile crollo del ponte Morandi, con il pensiero alla collega Anna, che aspettava di poter rientrare nella sua casa per recuperare almeno i ricordi più cari, mi sono chiesta anch’io che cosa, in quelle circostanze, avrei salvato dal mio appartamento. Mi ha colpito il fatto che nella mia lista virtuale, piena di oggetti cari, ci fosse solo uno dei moltissimi libri che riempono la mia casa, e non uno di quelli che ho comprato io. Era la Divina Commedia che apparteneva al mio nonno paterno. L’edizione è del 1915 e la rilegatura in stoffa è consumata, tanto che le incisioni sul piatto anteriore si leggono a malapena. Il nonno, che ha scritto il suo nome sul frontespizio e sul foglio di guardia posteriore, ha sottolineato solo tre delle terzine del poema, quelle dedicate all’amore nel canto di Paolo e Francesca:
«Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, Amor, ch’a nullo amato amar perdona, Amor condusse noi ad una morte.
Non ho mai conosciuto il nonno, morto prima che io nascessi, ma la sua sottolineatura su quei versi così belli me lo ha sempre fatto sentire più vicino delle tante fotografie rimaste di lui. Che grande potere ha Dante!
Forse, in questo periodo di forzata inattività, anche voi vorrete riprendere in mano la Commedia. Non con l’ansia di una interrogazione, ma per riascoltarne i versi con maggiore piacere, lo stesso che si prova a leggere i Promessi sposi da adulti. Vedrete, sarà come ritrovare un vecchio amico, nell’attesa del giorno – che speriamo venga presto – in cui anche noi usciremo finalmente di casa
«a riveder le stelle».
Andrà tutto bene, restate a casa. Lasciate che siamo noi a raggiungervi, attraverso la rete, confidando che presto potremo tornare a farlo di persona. Un forte e caro abbraccio. Giustina Olgiati
ai navicanti e ‘ntenerisce il core
lo dì c’han detto ai dolci amici addio;
punge, se ode squilla di lontano
che paia il giorno pianger che si more».
Siena mi fé, disfecemi Maremma:
salsi colui che ‘nnanellata pria
disposando m’avea con la sua gemma».
ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso.
ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei».
Vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare»
per l’universo penetra, e risplende
in una parte più e meno altrove»
o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate».
cominciò a crollarsi mormorando,
pur come quella cui vento affatica;
come fosse la lingua che parlasse,
gittò voce di fuori e disse: «Quando
me più d’un anno là presso a Gaeta,
prima che sì Enëa la nomasse,
del vecchio padre, né ‘l debito amore
lo qual dovea Penelopè far lieta,
ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto
e de li vizi umani e del valore;
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual non fui diserto».
quando venimmo a quella foce stretta
dov’ Ercule segnò li suoi riguardi
da la man destra mi lasciai Sibilia,
da l’altra già m’avea lasciata Setta.
perigli siete giunti a l’occidente,
a questa tanto picciola vigilia
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”.
con questa orazion picciola, al cammino,
che a pena poscia li avrei ritenuti;
de’ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino».
per la distanza, e parvemi alta tanto
quanto veduta non avëa alcuna.
ché de la nova terra un turbo nacque
e percosse del legno il primo canto.
a la quarta levar la poppa in suso
e la prora ire in giù, com’ altrui piacque,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Caina attende chi a vita ci spense”.
Queste parole da lor ci fuor porte».
Giustina Olgiati
In ricordo di Anne, di Etty e di troppi altri
La Settimana Santa, che cade in questi giorni in cui si parla solo di coronavirus, mi riporta alla mente la Passione di Cristo come simbolo delle sofferenze del genere umano. L’ho compreso appieno nel 2017, durante gli ultimi giorni di vita di Rina, la mia piccola, devota, affettuosissima suocera. Lei, che nella vita ne aveva passate tante, apparteneva a quella generazione che attribuiva ogni tipo di dolore alla volontà del Signore. Forse per questo le sue telefonate, anche nelle giornate più brutte, si concludevano invariabilmente con la frase ottimistica “Mah, speriamo tutto bene”. La sua lunga agonia, durata per tutta la Settimana Santa, è finita il 17 aprile, lunedì dell’Angelo. Da allora mi è impossibile pensare alle stazioni della Via Crucis senza ricordare il suo viso.
Forse quest’anno, nell’impossibilità di programmare vacanze fuori porta e pranzi con i parenti, qualcuno si soffermerà sul vero significato della Pasqua, come sacrificio necessario per la salvezza e la rigenerazione dell’Umanità. Personalmente, non riesco a disgiungere la grandezza del Disegno divino dalla sua realizzazione per mezzo dell’uomo – della parte peggiore degli uomini. Le tappe della Via Crucis sono la chiara ed evidente espressione della capacità degli uomini di accanirsi su altri uomini. E, per alcuni, della capacità di lavarsene le mani. E’ quella che, con felice intuizione e in riferimento a un diverso Olocausto, è stata definita “La banalità del male” . Che potrebbe essere fermata – e purtroppo lo è solo in rare occasioni – se ad essa si opponesse “La banalità del bene”, la forza della maggioranza silenziosa.
Oggi che dobbiamo restare in casa per evitare il contagio, vi invito a riflettere su quanti sono stati – in epoca non lontana – segregati senza colpa per la volontà dissennata di un dittatore che ne ha coinvolto altri, e di cui oggi vediamo ritornare alla ribalta il volto, le idee, i simboli, i gesti. Perché gli errori e gli orrori del passato non devono ripetersi, e senz’altro non devono farlo con la nostra complicità. Perché il silenzio non è altro che questo.
L’Olocausto è stato il genocidio, premeditato e pianificato, di ogni persona considerata indesiderabile per motivi razziali, politici, religiosi e non solo: ha avuto tra le sue vittime ebrei, zingari, disabili e malati di mente, omosessuali, oppositori politici e intellettuali, Testimoni di Geova e pentecostali, preti cattolici, prigionieri di guerra, popolazioni slave dei territori occupati. In tutto, secondo un calcolo approssimativo, oltre 15 milioni di persone. Tra questi, circa 6 milioni di ebrei.
Di tutto questo abbondano le prove: i campi di concentramento e quanto ancora contengono, i documenti che testimoniano la contabilità dello sterminio, gli atti dei processi, i filmati e le foto scattate dopo la liberazione, le testimonianze dei sopravvissuti e di molte delle vittime. Della Shoà, lo sterminio degli ebrei, sono rimaste molte testimonianze. Rileggerle in funzione del presente e del futuro non è solo un atto di giustizia, ma un percorso di riflessione che potrà suggerirci una nuova solidarietà quando l’emergenza sarà passata, dal punto di vista medico, ma ne rimarranno gli effetti sull’economia, sulla società, su quelli che consideriamo i nostri valori. Ricordare il passato è senz’altro tra questi.
Se questo è un uomo
Voi che vivete sicuri
Primo Levi (31 luglio 1919 – 11 aprile 1987)
La persecuzione contro gli ebrei viene sancita ufficialmente, negli anni Trenta del XX secolo, dalla proclamazione di norme che ne limitano la libertà e li privano dei diritti civili. In Germania vengono promulgate nel 1933 e successivamente imposte in tutte la nazioni occupate dai nazisti. In Italia vengono applicate fin dal 1938 con le cosiddette leggi razziali:
Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938 – XVI, n. 1390 – Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la volontà della Nazione re d’Italia e imperatore d’Etiopia.
Art. 1 – All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2 – Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3 – A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.
Art. 4 – I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Ai cittadini ebrei viene inoltre vietato il lavoro nelle tipografie, la vendita di oggetti d’arte, il commercio dei libri, il possesso di apparecchi radio, la possibilità di essere insegnanti privati, di accedere alle biblioteche pubbliche, di far parte di associazioni culturali e sportive, di fare la guida e l’interprete.
In questo periodo, soprattutto ai più giovani, farebbe bene leggere – o rileggere con maggiore consapevolezza – la più famosa delle testimonianze, il Diario di
Anne Frank (Francoforte sul Meno, 12 giugno 1929 – Bergen-Belsen, febbraio-marzo 1945). Immagine n. 1
Annelies Marie Frank, universalmente nota come Anne, è divenuta il simbolo della Shoah, al punto che il suo nome e il suo volto sono stati fatti oggetto, in tempi recenti, di scritte ingiuriose, cori da stadio e stampe su magliette e adesivi, testimonianza vergognosa quanto becera di quei nuovi sussulti di antisemitismo che purtroppo si registrano in maniera sempre più preoccupante nel nostro Paese.
https://www.repubblica.it/politica/2017/10/24/news/siamo_tutti_anna_frank-179162081/
La famiglia Frank – Otto, la moglie Edith e le figlie Margot e Anne – lascia la Germania dopo l’ascesa al potere di Hitler e si trasferisce ad Amsterdam. La conquista dell’Olanda nel 1940 impone anche su questo paese le leggi razziali. Il 6 luglio 1942 i Frank si trasferiscono in un rifugio ricavato nell’edificio sede della ditta di Otto; lo divideranno con un suo socio in affari (Hermann van Pels con la moglie e il figlio Peter: nel diario, la famiglia van Daan), e con un quarto rifugiato, il dentista Fritz Pfeffer (nel diario chiamato Albert Dussel).
Nei 25 mesi trascorsi nel rifugio, grazie all’assistenza di alcuni dei dipendenti ariani di Otto, Anne passa dall’infanzia all’adolescenza: studia, coltiva il sogno di diventare scrittrice, vive i primi – brevi, per sua stessa volontà – palpiti d’amore per Peter, partecipa con profonda pietà, ma senza perdere la speranza nel futuro, alle tragedie della guerra e delle persecuzioni razziali.
I brani che seguono sono tratti dall’edizione del Diario pubblicato da Einaudi nel 1974, nella traduzione di Arrigo Vita. Potete leggere la prefazione scritta da Natalia Ginzburg su
Sabato, 20 giugno 1942 «I bei tempi finirono nel maggio 1940; prima la guerra, la capitolazione, l’invasione tedesca, poi cominciarono le sventure per noi ebrei. Le leggi antisemitiche si susseguivano l’una all’altra. Gli ebrei debbono portare la stella giudaica. Gli ebrei debbono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono salire in tram, gli ebrei non possono più andare in auto. Gli ebrei non possono fare acquisti che fra le tre e le cinque, e soltanto dove sta scritto “bottega ebraica”. Gli ebrei dopo le otto di sera non possono essere per strada, né trattenersi nel loro giardino o in quello di conoscenti. Gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento, gli ebrei non possono praticare sport all’aperto, ossia non possono frequentare piscine, campi di tennis o di hockey eccetera. Gli ebrei non possono nemmeno andare a casa di cristiani. Gli ebrei debbono studiare soltanto nelle scuole ebraiche». Giovedì, 19 novembre 1942
Mercoledì, 13 gennaio 1943 «Fuori, è spaventoso. Di giorno e di notte quei poveretti vengono trascinati via, senza poter portare con sé che un sacco da montagna e un po’ di denaro. Durante il viaggio gli tolgono anche quel po’ di roba. Le famiglie vengono divise, gli uomini di qua, le donne di là, i bambini da un’altra parte. I bambini, venendo a casa da scuola, non trovano più i loro genitori. Le donne, tornando dal far le spese, trovano la casa sigillata e la famiglia scomparsa. Anche gli olandesi cristiani hanno paura; i loro figli sono spediti in Germania, tutti vivono nell’angoscia. E ogni notte centinaia di aviatori passano sull’Olanda, diretti verso le città tedesche, e là arano la terra con le bombe; e ogni ora cadono in Russia e in Africa centinaia, migliaia di uomini. Nessuno può starne fuori, tutto il mondo è in guerra e, sebbene vada meglio per gli alleati, non si vede ancora la fine. E noi… noi stiamo bene, meglio che milioni di altre persone. Siamo ancora tranquilli e sicuri e, come suol dirsi, ci mangiamo il capitale. Siamo così egoisti che parliamo di un “dopoguerra”, ci rallegriamo pensando che avremo vestiti nuovi e scarpe nuove, mentre veramente dovremmo risparmiare ogni centesimo per aiutare gli altri, dopo la guerra, a salvare quello che è ancora salvabile. I bambini qui vanno in giro con bluse leggere e zoccoli ai piedi, senza mantello, senza berretto, senza calze, e nessuno che li aiuti. Non hanno niente in pancia e masticano carote, lasciano la casa fredda per scendere nella strada fredda e andare a scuola in una classe ancor più fredda. Si è arrivati al punto, in Olanda, che moltissimi bambini fermano i passanti in strada per chiedere un pezzo di pane. Potrei passar delle ore a raccontarti le miserie portate dalla guerra, ma ciò mi rende ancor più triste. Non ci resta altro che aspettare tranquillamente, fin che si può, la fine di questa miseria. Aspettano gli ebrei e aspettano i cristiani, tutto il mondo aspetta, e molti aspettano la morte». Martedì, 15 giugno 1943 «E’ proprio vero; quando le notizie di fuori peggiorano, la radio con la sua voce miracolosa ci aiuta a non perderci di coraggio ripetendo continuamente: «Su, state di buon animo, verranno tempi migliori!».
Domenica, 11 luglio 1943
Lunedì, 8 novembre 1943 «Non so nemmeno immaginare che il mondo un giorno torni normale per noi. Ho un bel parlare di “dopoguerra”, ma è come se parlassi di castelli in aria che non diverranno mai realtà. Penso alla nostra casa di prima, alle amiche, alle feste scolastiche, come penserei a cose di cui un altro ha fatto esperienza, non io. L’alloggio segreto col nostro gruppo di otto rifugiati mi sembra uno squarcio di cielo azzurro attorniato da nubi nere, cariche di pioggia. L’area rotonda e circoscritta su cui stiamo è ancora sicura, ma le nubi si avvicinano sempre di più a noi e sempre più stretto diventa il cerchio che ci separa dal pericolo incombente. Siamo immersi nelle tenebre e nel pericolo e urtiamo gli uni contro gli altri cercando disperatamente una via di salvezza. Guardiamo tutti in basso dove gli uomini combattono, guardiamo in alto dove regnano la quiete e la bellezza, e intanto siamo tagliati fuori da quella tetra massa che non ci lascia salire in alto ma sta dinanzi a noi come un muro impenetrabile, che ci vuol schiacciare ma non può ancora. Non posso far altro che gridare e implorare: “O cerchio, o cerchio, allargati, apriti, lasciaci uscire!”».
Venerdì, 24 dicembre 1943 Sabato, 12 febbraio 1944 Mercoledì, 23 febbraio 1944 «Da ieri il tempo è splendido fuori, e io sono molto animata. Vado quasi ogni mattina nel solaio, dove lavora Peter, per liberarmi i polmoni dall’aria viziata della stanza. Mi siedo per terra nel mio posticino preferito e guardo il cielo azzurro, il castagno brullo sui cui rami scintillano piccole goccioline, i gabbiani e gli altri uccelli che fendono l’aria e sembrano argentati. … Ma guardavo anche dalla finestra aperta, sopra un grande settore di Amsterdam, sopra i tetti fino all’orizzonte tanto luminoso e azzurro che la linea di separazione non era chiaramente visibile. «Finché questo c’è ancora – pensai – e io posso godere questo sole, questo cielo senza nuvole, non ho il diritto di essere triste». Per chi ha paura o si sente incompreso e infelice, il miglior rimedio è andar fuori all’aperto, in un luogo dove egli sia completamente solo, solo col cielo, la natura e Dio. Soltanto allora, infatti, soltanto allora si sente che tutto è come deve essere, e che Dio vuol vedere gli uomini felici nella semplice bellezza della natura. Finché ciò esiste, ed esisterà sempre, io so che in qualunque circostanza c’è un conforto per ogni dolore. E credo fermamente che ogni afflizione può essere molto lenita dalla natura. … Qui ci manca molto, moltissimo, e da molto tempo, e tanto a me quanto a te. Non mi riferisco alle cose esteriori – qui ne siamo provvisti sufficientemente, – ma a quelle interiori. Desidero intensamente, come te, l’aria e la libertà di cui siamo privi, ma credo che per queste privazioni siamo largamente compensati. Me ne resi conto improvvisamente stamane quando sedevo dinanzi alla finestra. Intendo parlare di compensi interiori. Quando guardavo fuori, immergendomi nella profondità di Dio e della natura, mi sentivo felice, assolutamente felice. Peter, finché c’è questa felicità interiore, questo godere della natura, della salute e di tante altre cose, finché si ha tutto questo si tornerà sempre a essere felici. Ricchezza, fama, tutto puoi perdere, ma questa felicità nell’intimo del tuo cuore può soltanto velarsi, e si rinnoverà sempre finché vivrai. Finché puoi guardare il cielo senza timore, sappi che sei intimamente puro e che ridiverrai comunque felice».
Martedì, 7 marzo 1944 Mercoledì, 5 aprile 1944 Mercoledì, 3 maggio 1944
Venerdì, 26 maggio 1944 «Mi domando sempre se non sarebbe stato meglio che avessimo rinunciato a nasconderci. A quest’ora saremmo già morti senz’essere passati per queste miserie e, ciò che più conta, i nostri protettori non correrebbero alcun pericolo. Eppure rifuggiamo tutti da questo pensiero, amiamo ancora la vita, non abbiamo dimenticato la voce della natura, speriamo ancora, speriamo a dispetto di tutto. Pur che succeda presto qualche cosa, magari una bomba; non ci potrà fare a pezzi più di quanto faccia questa inquietudine. Pur che venga presto la fine, anche se dura, allora sapremo almeno se avremo vinto o se dovremo soccombere».
Giovedì, 15 giugno 1944 «E’ perché da tanto tempo non metto più il naso fuori di casa che vado pazza per le bellezze naturali? So benissimo che una volta l’azzurro del cielo, il cinguettio degli uccelli, il chiaro di luna e gli alberi in fiore non attiravano la mia attenzione. Qui le cose sono cambiate. La sera di Pentecoste, per esempio, sebbene facesse tanto caldo, mi sono sforzata di tenere gli occhi aperti fino alle undici e mezza, per potere tranquillamente contemplare da sola la luna attraverso la finestra aperta. Purtroppo questo sacrificio non servì a nulla, perché la luna spandeva troppa luce e io non potevo rischiare di tenere la finestra aperta. Un’altra sera, parecchi mesi addietro, mi trovavo per caso di sopra mentre la finestra era aperta. Non ritornai sotto se non quando la finestra dovette essere chiusa. La buia sera piovosa, la tempesta, le nubi che si rincorrevano per il cielo mi affascinavano; era la prima volta dopo un anno e mezzo che mi trovavo faccia a faccia con la notte. Dopo quella sera il mio desiderio di rivedere quello spettacolo fu più grande che la paura dei ladri, dei topi e delle incursioni. Me ne andavo tutta sola al piano di sotto per guardare fuori dalla finestra dell’ufficio privato o della cucina. Molti trovano bella la natura, molti dormono qualche volta all’aria aperta, molti, nelle prigioni o negli ospedali, sospirano il giorno in cui, liberi, potranno nuovamente godere la natura, ma pochi sono, come noi, chiusi con la loro nostalgia e isolati da ciò che è patrimonio sia del povero che del ricco. Non è una mia fantasia che la vista del cielo, delle nubi, della luna e delle stelle mi renda tranquilla e paziente. E’ una medicina migliore della valeriana o del bromuro. La natura mi rende umile e pronta ad affrontare valorosamente ogni avversità. Purtroppo è andata così: io non posso guardare la natura – ed eccezionalmente – che attraverso finestre polverose e coperte da sporche tendine. E guardarla così non è più un piacere, perché la natura è davvero l’unica cosa che non tollera surrogati». E’ vero che qui gli adulti trovano maggiori difficoltà che i giovani? No, non è affatto vero. Gli anziani hanno un’opinione su tutto, e nella vita non esitano più prima di agire. A noi giovani costa doppia fatica mantenere le nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annientato e distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato peggior, in cui si dubita della verità, della giustizia e di Dio. Chi ancora afferma che qui nell’alloggio segreto gli adulti hanno una vita più difficile, non si rende certamente conto della gravità e del numero dei problemi che ci assillano, problemi per i quali forse noi siamo troppo giovani, ma che ci incalzano di continuo, sino a che, dopo lungo tempo, noi crediamo di aver trovato una soluzione; ma è una soluzione che non sembra capace di resistere ai fatti, che la annullano. Ecco la difficoltà di questi tempi: gli ideali, i sogni, le splendide speranze non sono ancora sorti in noi che già sono colpiti e completamente distrutti dalla crudele realtà. E’ un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l’ordine, la pace, la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei ideali; verrà un tempo in cui saranno forse ancora attuabili».
Traditi da un delatore che non sarà mai identificato con certezza, gli otto rifugiati – arrestati dai nazisti il 4 agosto 1944 – vengono trasferiti a Westerbork, il campo di concentramento utilizzato come luogo di transito e smistamento degli ebrei olandesi verso i campi di sterminio. Il 2 settembre vengono deportati ad Auschwitz. Solo Otto Franz riuscirà a sopravvivere. Anne e Margot muoiono di tifo a Bergen-Belsen nel febbraio 1945.
Etty (Esther) Hillesum (Middelburg, 15 gennaio 1914 – Auschwitz, 30 novembre 1943)
Etty Hillesum è stata la donna che Anne Frank sarebbe potuta diventare. Cresciuta in un ambiente colto (il padre studioso di lingue classiche, i fratelli Mischa e Jaap rispettivamente pianista di grande talento e medico), laureata in Giurisprudenza e iscritta alla facoltà di Lingue Slave, Etty si trasferisce prima dell’inizio della guerra ad Amsterdam, dove entra in contatto con gli ambienti accademici e con la resistenza studentesca di sinistra. Impiegata come dattilografa in una delle sezioni del Consiglio Ebraico, nell’agosto 1943 si trasferisce a Westerbork, dove presta servizio nell’ospedale del campo che costituisce per i deportati l’ultima tappa del viaggio verso Auschwitz. Gli scritti rimasti di lei sono testimonianza di una vita intensa, nella quale l’amore umano, sentimentale e fisico, coesiste con un colloquio sempre più frequente con un Dio nel quale sembrano fondersi la spiritualità ebraica con quella cristiana. A questa sorta di misticismo si accompagnano una sensibilità profonda nei confronti delle sofferenze umane e una personalità definita “luminosa” dai sopravvissuti del campo.
Etty muore ad Auschwitz il 30 novembre 1943. Nessuno della famiglia Hillesum è sopravvissuto.
I suoi scritti sono stati pubblicati in Italia dalla casa editrice Adelphi: Diario (1941-1943), a cura di J.G. Gaarlandt, nel 1985. Lettere (1942-1943), a cura di Chiara Passanti, nel 1990.
Amsterdam, dicembre 1942 «Certo, accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto possibili. Ma forse possediamo altri organi oltre alla ragione, organi che allora non conoscevamo, e che potrebbero farci capire questa realtà sconcertante. Io credo che per ogni evento l’uomo possieda un organo che gli consente di superarlo. Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si conserva. A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, possa arricchire l’uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare – se non li ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farli decantare e divenire fattori di crescita e di comprensione –, allora non siamo una generazione vitale. Certo che non è così semplice, e forse meno che mai per noi ebrei; ma se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient’altro che i nostri corpi salvati a ogni costo – e non un nuovo senso delle cose, attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione –, allora non basterà. Dai campi stessi dovranno irraggiarsi nuovi pensieri, nuove conoscenze dovranno portar chiarezza oltre i recinti di filo spinato, e congiungersi con quelle che là fuori ci si deve ora conquistare con altrettanta pena, e in circostanze che diventano quasi altrettanto difficili. E forse allora, sulla base di una comune e onesta ricerca di chiarezza su questi oscuri avvenimenti, la vita sbandata potrà di nuovo fare un cauto passo avanti. Per questo mi sembrava così pericoloso sentir ripetere: “Non vogliamo pensare, non vogliamo sentire, la cosa migliore è diventare insensibili a tutta questa miseria”. Come se il dolore – in qualunque forma ci tocchi incontrarlo – non facesse veramente parte dell’esistenza umana».
Se Anne ed Etty hanno potuto lasciarci testimonianza della loro fede nel futuro, è rimasta invece senza voce l’infanzia negata di più di un milione di bambini, destinati fin dal loro arrivo nei campi alle camere a gas (immagine n. 2) o a pseudo-scientifici esperimenti disumani. I loro volti sorridenti rimangono nei ritratti di famiglia, l’orrore del loro destino nelle foto di gruppo dietro ai fili spinati. Il ricordo di alcuni di loro – troppo pochi – ci giunge attraverso le parole dei sopravvissuti:
«Hurbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero; Hurbinek, che aveva combattuto come un uomo, fino all’ultimo respiro, per conquistarsi l’entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie parole» (Primo Levi, La tregua).
I bambini di Terezin
Sono rimasti invece tanti disegni, scritti e poesie dei 15.000 bambini passati tra il 1941 e il 1945 attraverso il campo di Terezin (Theresienstadt) prima di essere deportati ad Auschwitz e Treblinka. Pochi di loro sono sopravvissuti. Su Terezin, utilizzato dai nazisti come luogo di propaganda, potete trovare moltissime informazioni sul web. Vi segnalo alcuni indirizzi, tra i quali una pubblicazione in pdf del Ministero dell’Istruzione:
https://www.istruzione.it/allegati/2015/Pubblicazione_Shoah.pdf https://it.wikipedia.org/wiki/Bambini_di_Terez%C3%ADn http://www.igiornielenotti.it/shoah-poesie-dei-bambini-del-ghetto-di-terezin-2/
I bambini del campo sono stati definiti “Le farfalle di Terezin” in omaggio al disegno della piccola Doris Weiserova (nata il 17 maggio 1932 – morta ad Auschwitz il 4 ottobre 1944) immagine n. 3, e a questa poesia:
La farfalla L’ultima, proprio l’ultima, / di un giallo così intenso, così / assolutamente giallo, / come una lacrima di sole quando cade / sopra una roccia bianca / così gialla, così gialla! / l’ultima, / volava in alto leggera, / aleggiava sicura / per baciare il suo ultimo mondo. / Tra qualche giorno / sarà già la mia settima settimana / di ghetto: / i miei mi hanno ritrovato qui / e qui mi chiamano i fiori di ruta / e il bianco candeliere di castagno / nel cortile. / Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. / Quella dell’altra volta fu l’ultima: / le farfalle non vivono nel ghetto.
Pavel Friedman, Praga 1921 – Auschwitz 1944
Qualunque commento agli scritti di questi bambini sarebbe irrispettoso e superfluo.
«… Siamo abituati a piantarci su lunghe file alle sette del mattino, a mezzogiorno e alle sette di sera, con la gavetta in pugno, per un po’ di acqua tiepida dal sapore di sale o di caffè o, se va bene, per qualche patata. Ci siamo abituati a dormire senza letto, a salutare ogni uniforme scendendo dal marciapiede e risalendo poi sul marciapiede. Ci siamo abituati agli schiaffi senza motivo, alle botte e alle impiccagioni. Ci siamo abituati a vedere la gente morire nei propri escrementi, a vedere salire in alto la montagna delle casse da morto, a vedere i malati giacere nella loro sporcizia e i medici impotenti. Ci siamo abituati all’arrivo periodico di un migliaio d’infelici e alla corrispondente partenza di un altro migliaio di esseri ancora più infelici …».
Petr Fischl, nato a Praga il 9/9/1929, deportato a Terezin l’8/12/1943, morto ad Auschwitz l’8/10/1944. Un altro bambino con lo stesso nome è tra i sopravvissuti alla Shoah.
* A Terezin Ogni cosa gli sembra strana. / Come, devo coricarmi per terra? / No, io non mangerò quella sudicia patata nera. / E questa sarà la mia casa? Dio com’è lurida! / Il pavimento è solo fango e sporcizia. / E qui io dovrei distendermi. / Come farò senza sporcarmi? / C’è sempre un gran movimento quaggiù / e tante tante mosche: / le mosche non portano le malattie? / Ecco, qualcosa mi ha punto: un cimice forse. / Com’è orribile Terezin! / Chissà quando ritorneremo a casa.
“Teddy”: dati anagrafici non accertati, 1943
* La sera a Terezin Tramonta il sole e il silenzio intorno regna; / soltanto giù presso la garitta dei gendarmi /si sentono passi pesanti. / Così il gendarme sorveglia gli Ebrei suoi, / che non fuggano dal ghetto,/ e per non / far venire qui da loro ariani/ lo zio o la zia. / La decima ora a un tratto è giunta, / e le finestre della caserma dei Dresdesi si sono oscurate. / Le donne si scambiano diverse dicerie, / ricordano quando a casa avevano da mangiare. / Alcune litigano, poi / altre alla calma invitano. / Finalmente una dopo l’altra tacciono, / qui e là si gira finché ci si addormenta: / quante sere così ancora proveremo? / Questo noi non sappiamo, / questo il Signore Iddio soltanto sa.
Eva Schubzovà, nata nel 1931, morta nel 1941-43
* Addio estate Come voi vorrei, poeti, dilungarmi / Sulla fine della primavera, e sull’amore, / sui giorni di sole, / sulle dolci serate di ingannevole luna / sugli uccelli, sui fiori e sugli alberi in / germoglio./ Come voi vorrei, liberi, dar l’addio / e passeggiare nei boschetti, lungo il fiume tra / gli alberi da frutto / così, come un tempo, quando c’era tra noi / somiglianza e quando non ero, / così come oggi, stremato. / Come voi vorrei all’estate dar l’addio. / Con il sole pulito, che attraverso le sbarre non / Risplende. / Coccolarsi per un istante con l’appassente / bocciolo. / Non posso, non posso, sono in carcere / Rinchiuso.
Zdenek Ohrenstein (1929-1990)
* Nostalgia della casa È più di un anno che vivo al ghetto, / nella nera città di Terezìn, / e quando penso alla mia casa / so bene di che si tratta./ O mia piccola casa, mia casetta, / perché m’hanno strappato da te, / perché m’hanno portato nella desolazione, / nell’abisso di un nulla senza ritorno? / Oh, come vorrei tornare / a casa mia, fiore di primavera! / Quando vivevo tra le sue mura / io non sapevo quanto l’amavo! / Ora ricordo quei tempi d’oro: / presto ritornerò, ecco, già corro. / Per le strade girano i reclusi / e in ogni volto che incontri / tu vedi che cos’è questo ghetto, / la paura e la miseria. / Squallore e fame, questa è la vita / che noi viviamo quaggiù, / ma nessuno si deve arrendere: / la terra gira e i tempi cambieranno. / Che arrivi dunque quel giorno / In cui ci rivedremo, mia piccola casa! / Ma intanto preziosa mi sei / Perché mi posso sognare di te.
Zdenek Ohrenstein (1929-1990)
* Terezìn Una macchia di sporco dentro sudice mura / e tutt’attorno il filo spinato / 30.000 ci dormono / e quando si sveglieranno / vedranno il mare / del loro sangue. / Sono stato bambino tre anni fa. / Allora sognavo altri mondi. / Ora non sono più un bambino, / ho visto gli incendi / e troppo presto sono diventato grande. / Ho conosciuto la paura, / le parole di sangue, i giorni assassinati: / dov’è il babau di un tempo? / Ma forse questo non è che un sogno / e io ritornerò laggiù con la mia infanzia. / Infanzia, fiore di roseto, / mormorante campana dei miei sogni, / come madre che culla il figlio / con l’amore traboccante / della sua maternità. / Infanzia, miserabile catena / che ti lega al nemico e alla forca. / Miserabile infanzia, che dentro / il suo squallore / già distingue il bene e il male. / Laggiù dove l’infanzia dolcemente / riposa / nelle piccole aiuole di un parco, / laggiù, in quella casa, qualcosa si è / spezzato / quando su me è caduto il disprezzo: / laggiù, nei giardini o nei fiori / o sul seno materno, dove io sono nato / per piangere… / Alla luce di una candela m’addormento / forse per capire un giorno / che io ero una ben piccola cosa, / piccola come il coro dei 30.000, / come la loro vita che dorme / laggiù nei campi / che dorme e si sveglierà, / aprirà gli occhi / e per non vedere troppo / si lascerà riprendere / dal sonno…
Hanus Hachenburg, nato il 12.7.1929 – morto il 18.12.1943 ad Auschwitz
* La paura Di nuovo l’orrore ha colpito il ghetto, / un male crudele che ne scaccia ogni altro. / La morte, demone folle brandisce una gelida falce / Che decapita intorno le sue vittime. / I cuori dei padri battono oggi di paura / E le madri nascondono il viso nel grembo. / La vipera del tifo strangola i bambini / E preleva le sue decime dal branco. / Oggi il mio sangue pulsa ancora, / ma i miei compagni mi muoiono accanto. / Piuttosto di vederli morire / Vorrei io stesso trovare la morte. / Ma no, mio Dio, noi vogliamo vivere ! / Non vogliamo vuoti nelle nostre file. / Il mondo è nostro e noi lo vogliamo migliore. / Vogliamo fare qualcosa. E’ vietato morire !
Eva Pickova, nata il 15.5.29, morta il 18.12.43 ad Auschwitz.
* Vedrai che è bello vivere Chi s’aggrappa al nido / non sa che cos’è il mondo, / non sa quello che tutti gli uccelli sanno / e non sa perché voglia cantare / il creato e la sua bellezza. / Quando all’alba il raggio del sole / illumina la terra / e l’erba scintilla di perle dorate, / quando l’aurora scompare / e i merli fischiano tra le siepi, / allora capisco come è bello vivere. / Prova, amico, ad aprire il tuo cuore alla bellezza / quando cammini tra la natura / per intrecciare ghirlande coi tuoi ricordi: / anche se le lacrime ti cadono lungo la strada, / vedrai che è bello vivere.
Anonimo, 1941
Se mi avete seguito fin qui meritate un regalo: il percorso per ascoltare il discorso di Liliana Segre al Parlamento europeo in occasione della Giornata della Memoria del 2020.
https://www.affarinternazionali.it/2020/01/il-discorso-integrale-di-liliana-segre/
La sua testimonianza vale più di ogni parola che io potrei mai scrivere. Ho già espresso molte volte, a voce, la mia ammirazione per questa donna straordinaria. Colgo ora l’occasione per ringraziare, oltre a lei, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che l’ha nominata, nel 2018, tra i Senatori a Vita: quella parte del nostro Parlamento della quale andiamo sempre, giustamente, orgogliosi.
Andrà tutto bene, restate a casa. Non guardatela come una prigione, ma come un nido che ci accoglie e ci protegge. Questa forzata inattività ci lascia tanto tempo per riflettere e, come spero, per diventare migliori. Anche nel ricordo dei tanti, troppi, ai quali questa possibilità è stata negata. Un forte e caro abbraccio. Giustina Olgiati
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un si o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.
«Dussel ci ha raccontato molte cose del mondo di fuori, di cui non facciamo più parte ormai da tanto tempo. Tristi, le cose che sa. Moltissimi amici e conoscenti sono partiti, per una terribile destinazione. Ogni sera le automobili militari verdi o grigie scorrazzano qua e là, i tedeschi suonano a ogni porta e domandano se lì abitano anche ebrei. Se sì, tutta la famiglia deve seguirli, se no, vanno oltre. Nessuno può sottrarsi alla sua sorte se non si nasconde. Talvolta vanno in giro con delle liste e suonano soltanto là dove sanno di poter fare una ricca preda. Spesso si paga un prezzo per il riscatto, tanto per testa. Sembra la caccia agli schiavi, come la si faceva un tempo. Ma non è affatto uno scherzo, è una cosa tragica. Di notte, al buio, quasi vedo quelle file di innocenti che, comandati da un paio di quei figuri, camminano, camminano, coi loro bimbi che piangono, battuti e martoriati, finché cadono al suolo. Nessuno è risparmiato, vecchi carichi d’anni, bimbi, donne incinte, malati, tutti camminano insieme nella marcia verso la morte. Come stiamo bene qui, bene e tranquilli! Avremmo bisogno di ignorare tutte queste miserie, ma siamo troppo angustiati per tutti coloro che ci erano cari e che non possiamo più aiutare. Mi sento cattiva, io che me ne sto in un letto caldo mentre le mie più care amiche sono state gettate chi sa dove o sono già morte. Che angoscia, pensare a tutti coloro con cui mi sono sempre sentita intimamente legata e che ora sono caduti in mano ai carnefici più crudeli che esistano! E tutto questo perché sono ebrei!»
«Miep lavora come una bestia da soma a portarci roba. Quasi ogni giorno scova da qualche parte della verdura per noi e se la carica sulla bicicletta in grosse borse da spesa. E’ pure lei che ogni sabato ci porta cinque libri della biblioteca. Noi aspettiamo con ansia il sabato appunto perché vengono i libri. Proprio come bambini che hanno da ricevere un regalo. Chi vive normalmente non può sapere che cosa significhino i libri per noialtri rinchiusi. Lettura, studio e radio sono le nostre distrazioni».
«Quando viene qualcuno di fuori, col vento negli abiti e il freddo in viso, vorrei ficcare la testa sotto le coperte per non pensare: “Quando ci sarà di nuovo concesso di respirare un po’ d’aria?”. E siccome non posso nascondere il capo nelle coperte, ma lo devo anzi tenere ben dritto, i pensieri vengono, e non una volta sola ma infinite volte. Credimi, quando sei stata rinchiusa per un anno e mezzo, ti capitano dei giorni in cui non ne puoi più. Sarò forse ingiusta e ingrata, ma i sentimenti non si possono reprimere. Vorrei andare in bicicletta, ballare, fischiettare, guardare il mondo, sentirmi giovane, sapere che sono libera, eppure non devo farlo notare perché, pensa un po’, se
tutti e otto ci mettessimo a lagnarci e a far la faccia scontenta, dove andremmo a finire? A volte mi domando: “Che non ci sia nessuno capace di comprendere che, ebrea o non ebrea, io sono soltanto una ragazzotta con un grande bisogno di divertirmi e stare allegra?”. Non lo so, e non potrei parlarne con nessuno, perché sono certa che mi metterei a piangere. Piangere può recare tanto sollievo».
«C’è un bel sole, il cielo è sereno, spira un vento delizioso, e io ho desiderio… di tutto. Desiderio di chiacchiere, di libertà, di amici, di esser sola. Desiderio… di piangere! mi sembra di dovere scoppiare, e so che se piangessi starei meglio; ma non posso. Sono inquieta, vado da una camera all’altra, respiro l’aria dalla fessura di una finestra chiusa, sento che il mio cuore batte, come se dicesse: “Soddisfa finalmente i miei desideri!”. Credo di sentire in me il risveglio della primavera, lo sento in tutto il mio corpo e nella mia anima. Debbo farmi forza per comportarmi normalmente, sono del tutto smarrita, non so che cosa leggere, che cosa scrivere, che cosa fare; so solamente che ho tanti desideri…!».
«Allora penso: “buona” è la sicurezza del nostro rifugio, è la mia salute, è la mia stessa esistenza; “caro” è Peter, è quel sentimento delicato e indistinto che noi due non osiamo ancora nominare, o sfiorare, ma che verrà, e sarà l’amore, l’avvenire, la felicità; “bello” è il mondo; il mondo, la natura, la bellezza e tutto ciò che la forma. Non penso a tutti i sofferenti, ma al bello che ancora rimane. In questo sono molto diversa da mamma, che a chi è di cattivo umore consiglia: «Pensa alle miserie che ci sono al mondo, e sii felice che tu non ne soffri!». Io invece consiglio: «Va’ fuori, al sole, nei campi, a contatto con la natura, va’ fuori e cerca di trovare la felicità in te e in Dio. Pensa al bello che c’è ancora in te e attorno a te e sii felice!».
… Chi è felice farà felici anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura!».
«Chi non scrive non sa quanto sia bello scrivere; in passato, rimpiangevo sempre di non sapere disegnare, ma ora sono felicissima di saper almeno scrivere. E se non avrò ingegno abbastanza per fare la scrittrice o la giornalista, ebbene, potrò sempre scrivere per me sola. Voglio farmi avanti, non posso pensare di vivere come mamma, la signora Van Daan e tutte quelle donne che fanno il loro lavoro e poi sono dimenticate. Debbo avere qualcosa a cui dedicarmi, oltre al marito e ai figli! Voglio continuare a vivere dopo la mia morte! Perciò sono grata a Dio che mi ha fatto nascere con quest’attitudine a evolvermi e a scrivere per esprimere ciò che è in me. Scrivendo dimentico tutti i miei guai, mi rianimo e la mia tristezza svanisce».
«Come ben ti puoi immaginare, qui dicono sovente, disperati: «A che cosa serve mai la guerra? Perché gli uomini non possono vivere in pace? Perché devastare tutto?». La domanda è comprensibile, ma finora nessuno ha ancora trovato una risposta soddisfacente. Già, perché in Inghilterra fanno aeroplani sempre più grandi, bombe sempre più pesanti e, nello stesso tempo, case prefabbricate in serie per la ricostruzione? Perché si spendono ogni giorno milioni per la guerra e nemmeno un centesimo per l’assistenza medica, per gli artisti, per i poveri? Perché gli uomini debbono soffrire la fame, quando in altre parti del mondo si lasciano marcire i cibi sovrabbondanti? Perché gli uomini sono così pazzi? Non credo affatto che la guerra sia soltanto colpa dei grandi uomini, dei governanti e dei capitalisti. No, la piccola gente la fa altrettanto volentieri, altrimenti i popoli si sarebbero rivoltati da tempo. C’è negli uomini un impulso alla distruzione, alla strage, all’assassinio, alla furia, e fino a quando tutta l’umanità, senza eccezioni, non avrà subito una grande metamorfosi, la guerra imperverserà: tutto ciò che è stato ricostruito o coltivato sarà distrutto e rovinato di nuovo; e si dovrà ricominciare da capo. Sono stata sovente abbattuta, ma mai disperata; considero questa vita clandestina come una avventura pericolosa, ma romantica e interessante. Mi consolo delle privazioni divertendomi a descriverle nel mio diario. Mi sono proposta di condurre una vita differente da quella delle altre ragazze e, più tardi, da quella delle solite donne di casa. Questo è il bell’inizio della vita interessante; e perciò, perciò soltanto, nei momenti più pericolosi, debbo ridere del lato umoristico della situazione. Sono giovane e posseggo molte virtù ancora nascoste, sono giovane e forte e vivo questa grande avventura, ci sono in mezzo e non posso passar la giornata a lamentarmi. La natura mi ha favorito dandomi un carattere felice, gioviale ed energico. Ogni giorno sento che la mia mente matura, che la liberazione si avvicina, che la natura è bella, che la gente attorno a me è buona, che quest’avventura è interessante. Perché dunque dovrei disperarmi?».
Sabato, 15 luglio 1944
«La gioventù, in fondo, è più solitaria della vecchiaia». Questa massima, che ho letto in qualche libro, mi è rimasta in mente e l’ho trovata vera.
04 Disegno, Pittura, Fotografia, Scrittura Creativa e nuovi linguaggi artistici
Enrica Carpaneto
Lieta di contribuire a questa bella iniziativa, vi inoltro qualcosa da leggere.
Guido Novali
La Fotografia è arte, documento, informazione, denuncia, passione e pensiero. Ha la capacità con una sola immagine di raccontare storie piccole e grandi e di renderle eterne.
Ecco un’immagine recente, esempio del valore della fotografia e della sua forza comunicativa ed evocativa:
Come una “foto di guerra”, perché in realtà è una foto di guerra, racconta più di quanto potrebbero fare mille parole non solo la lotta eroica di questi giorni terribili ma anche di quanto coraggio e spirito di sacrificio sono capaci le migliori persone. Resterà per sempre, “Infinito Istante”, testimonianza storica di quello che il nostro amato paese sta vivendo.
Uno scatto perfetto, che emoziona l’animo e racconta una grande storia umana.
08 Ecologia, Sviluppo Sostenibile e Conoscenza del Territorio
Antida Gazzola
Pubblicato in “La ballata. Rivista d’arte e cultura”, 3-4, 2018, pag.25
Beata solitudo sola beatitudo
A Venezia, nel chiostro del convento dei francescani sull’isoletta di San Francesco del Deserto, è ancora leggibile la scritta “Beata solitudo sola beatitudo”, motto di origine controversa, attribuito a grandi pensatori dell’antichità come Seneca. In realtà la sua prima comparsa documentata si trova nell’opera di Cornelis Musius, olandese, considerato un martire cattolico perché fu ucciso dai protestanti alla fine del 1500 durante la “guerra degli ottant’anni” tra le Province Unite (che diventeranno più tardi i Paesi Bassi) e la Spagna che ne aveva il dominio e che cercava di estirparne il protestantesimo – rapidamente diffusosi in quelle regioni – non solo perché era considerato eretico, ma anche perché metteva in dubbio l’autorità della chiesa di Roma su cui si fondava tutto il sistema sociopolitico delle grandi monarchie assolute come quella spagnola. Il povero Cornelis che era un onesto prete e un fine intellettuale, oltre che uomo tollerante e di buone intenzioni, venne crudelmente ucciso proprio dai protestanti, sostenitori della libertà, dell’uguaglianza e della democrazia per aver cercato di salvare i beni della sua chiesa. Fu schiacciato, come il manzoniano vaso di coccio, tra vasi di ferro al di là delle sue possibilità di controllo. Certo avrebbe preferito restare a studiare e a pregare nel monastero di Sant’Agata a Delft di cui era stato rettore per 35 anni. In quell’epoca di grandi e persistenti conflitti devastatori, la regione in cui viveva era comunque una delle più ricche e progredite d’Europa. Nelle Province Unite passavano, partivano, arrivavano prodotti di ogni genere, compresi quelli esotici provenienti da luoghi favolosi come i gelidi mari settentrionali in cui si cacciavano le balene o da esotiche contrade come l’India, l’Indonesia, l’Africa meridionale, il Brasile o le Indie Occidentali dove si trovavano popolazioni e merci fino ad allora poco conosciute. In Nord America, con notevole lungimiranza, gli olandesi fondarono, in un luogo singolarmente affascinante e difendibile, una città chiamata Nieuw Amsterdam, destinata a diventare una metropoli di successo con il nome di New York. Nell’arco di un secolo, tra il ‘500 e il ‘600, in quel piccolo territorio che oggi chiamiamo Olanda, spazzato dai venti e sottoposto ai capricci delle maree e delle tempeste del mare del Nord, vissero pensatori di grande peso per la cultura europea come, ad esempio, i filosofi Erasmo da Rotterdam e Baruch Spinoza, i pittori Hyronymus Bosch, Jan Vermeer, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Frans Hals, il giurista Ugo Grozio, il fisico e astronomo Christian Huygens e, last but not least, l’ingegnere idraulico Jan Adriaanzoon poi noto come Jan Leeghwater che, grazie al drenaggio con i mulini a vento, guadagnò alle Province Unite una larga parte di territori sottratti al mare. Eppure, in quell’epoca di fermenti civili, politici, scientifici, il buon Cornelis Musius invocava la solitudine come unica beatitudine. Era solo perché in solitudine era più facile per lui accedere alla mistica unione con Dio? O forse era sfinito dalle continue controversie religiose di cui, come si è visto, finirà vittima innocente? O perché la solitudine come la vita, secondo quello che dirà Cesare Pavese tre secoli più tardi, è un “vizio assurdo” a cui è pericoloso indulgere, al cui fascino è difficile sottrarsi e che si risolve solo con la morte? Ma c’è anche qualcuno, come George Moustaki, che la considera, con indulgenza, una ineludibile compagna dell’esistenza:
“Per avere così spesso dormito con la mia solitudine me ne sono fatta quasi un’amica una dolce abitudine.
Non mi lascia d’un passo, fedele come un’ombra mi ha seguito qua e là ai quattro angoli del mondo.
No, non sono mai solo Con la mia solitudine.”
D’altra parte qualcuno ha detto “Nella Bibbia è scritto che per l’uomo è male essere solo, ma, a volte, è un gran sollievo”. Ci sono persone che godono della solitudine, se ne inebriano con qualche senso di colpa e la difendono dalle più varie intromissioni. Sono coloro che sono stati educati alla solitudine fin da bambini, che ne hanno avuto paura e hanno dovuto trovare in sé il coraggio per accettarla e a poco a poco se ne sono fatti un habitus, un modo di essere, una veste impermeabile che nasconde, protegge, isola. La solitudine permette una libertà inebriante: nella propria sfera quotidiana, tutto, dalla successione temporale degli atti più minuti a ogni tipo di scelta, può essere deciso senza doverlo contrattare con nessuno, senza dover dare spiegazioni o chiedere permessi.
Antida Gazzola
Pubblicato in “La ballata. Rivista d’arte e cultura”, 3-4, 2012 pag. 25
Passo tra i passi
Alla fine di questa frase, comincerà la pioggia.
All’orlo della pioggia, una vela.
Lenta la vela perderà di vista le isole;
in una foschia se ne andrà la fede nei porti
di un’intera razza.
La guerra dei dieci anni è finita.
La chioma di Elena, una nuvola grigia.
Troia, un bianco accumulo di cenere
vicino al gocciolare del mare.
Il gocciolio si tende come una corda d’arpa.
Un uomo con gli occhi annuvolati raccoglie la pioggia
e pizzica il primo verso dell’Odissea.
Derek Walcott, Arcipelaghi, 1984 Negli spazi pieni di incanti e suggestioni del Museo Archeologico del Finale, è vissuta, per tutta questa estate, una mostra dei lavori di un grande artista contemporaneo, Selim Abdullah. Viene da lontano Selim, da quella Bagdad che fu grande capitale, crogiuolo di etnie, arti, scienze, luogo d’incontro e di trasmissione di saperi da quando i saggi abbasidi, nella profondità dell’ottavo secolo, traducevano dal greco e diffondevano l’eredità classica ed ellenistica. La “città circolare” esempio di sapienza costruttiva e gestionale, fu più volte invasa nei secoli che seguirono e le sue ricchezze materiali e immateriali ripetutamente disperse. È un luogo di nascita che pone molti interrogativi e non può non lasciare tracce incancellabili anche in chi, oggi, può essere definito un cittadino d’Europa e in cui convivono le esperienze fiorentine, quelle parigine e, in genere, le immagini di civiltà occidentali altrettanto segnate da cicli di tragedie, abbandoni, oblii. Dei lavori esposti molti aspetti mi colpiscono, ma il primo riguarda certamente – forse per deformazione professionale – la scarsità di figure singole. Ci sono uomini e donne rappresentati in gruppi di varie dimensioni a partire da due, la diade primigenia e fatale, per arrivare a uno scorrere, che pare infinito e che talvolta sembra non arrivare da nessuna parte e muoversi instancabilmente verso un non si sa dove, nel fluire incessante del tempo, costruendo la storia. Ci sono dipinti, sculture, materiali diversi, porcellana e terracotta, bronzo e legno: il cammino dell’uomo penetra nei diversi materiali, talvolta con fatica, con dolore, altre volte con leggerezza come i molti pesci che, sempre in banchi, compaiono in molte delle opere esposte, allegorici e realistici come nei mosaici di Piazza Almerina. Gruppi di piccole figure in bronzo, contemporaneamente carnali e metafisiche, vivono in nuclei densi di relazioni fisiche e affettive (si toccano, si abbracciano, si respingono) in cima ad aste rigide e lineari appoggiate su basamenti duri come il metallo o fragili come la terracotta o la porcellana. A me, ignorante delle arti figurative che pure mi attraggono tanto, evocano il duro e continuo rapporto con la realtà e il desiderio di comprenderla e trascenderla. Non riesco a non pensare al “Fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e canoscena” di Dante Alighieri, al suo Ulisse che sfida le colonne d’Ercole, per mare, con un esiguo gruppo di compagni, per l’insopprimibile desiderio di conoscere. Quel mare – che i latini e i loro discendenti chiamarono arbitrariamente Mare Nostrum – compare spesso nei lavori esposti in questa mostra, percorso da popoli in transito, delle più varie provenienze, portatori, da sempre, come si può constatare anche dai reperti esposti nel Museo Archeologico, di oggetti, di saperi, delle loro specificità umane prima ancora che etniche. L’accostamento di questi lavori odierni e senza tempo ai contenuti stabili del Museo, che vengono da così lontano nel passato, produce effetti straordinari, dà il senso della continuità dell’evoluzione umana, del viaggio continuo dell’uomo nel tempo e nello spazio, con gesti, produzioni, affetti così simili e declinati in unamiriadi di varianti tutte riconoscibili come appartenenti alla nostra esperienza. Ma ciò che trovo più affascinante è il rapporto tra i gruppi di personaggi in bronzo e le basi in terracotta, tra la forza dell’uomo, la sua capacità di superare drammi, disfatte, difficoltà, e quello che (la terracotta) per me rappresenta l’ambiente di vita, sempre più suscettibile di venire sgretolato da quella stessa umanità che ne è ospitata, “questo mondo fragile/ un istante che ci è sottomesso”, come diceva Louis Aragon. Visitando la mostra, con la letizia interiore che viene dalla bellezza comunicata e raccolta, sentivo agitarsi in me i ricordi provenienti dalla mia educazione classica; versi di antichi poeti greci e latini giravano sbocconcellati ma ancora riconoscibili nella mia mente; e poi il Rinascimento, il Museo archeologico di Salonicco, Giacometti e ancora Chatwin e le vie dei canti, Walcott e la mappa del nuovo mondo, Celan e Benjamin vaganti di soglia in soglia e tutto ciò che la poesia espressa in ogni arte ci dà consentendoci di vedere ciò che, altrimenti, sarebbe oscuro.
Antida Gazzola
Pubblicato in La Ballata. Rivista d’arte e cultura, 1, 2005, pag. 25
Le mie case
È quella che ritorna nei sogni che muoiono all’alba. La prima. L’archetipo di tutte le case. È il luogo in cui sono giunta, neonata, in braccio a mio padre, appena scesa dal civico ospedale collocato appena qualche centinaio di metri più a monte. Nella mia mente l’immagine si sdoppia. C’è il ricordo di un edificio che mi pareva strano, rispetto a quelli vicini – semplici alloggi di quella che, molto prima che io venissi al mondo, era stata la periferia a levante della città – e a cui si accedeva o da una strada veicolare molto ripida che pochi percorrevano, o da una infinita teoria di scale esterne che si arrampicavano sulla collina. Oggi so di aver vissuto in un bell’esempio di edificio razionalista degli anni trenta, in cemento armato, con qualche cedimento rétro solo nelle decorazioni interne. E certamente migliore sia delle vecchie case che lo circondavano sia dei condomini degli anni sessanta che facevano parte delle mie ambizioni. In uno di questi transitai senza grande entusiasmo durante il periodo dell’università, dopo aver spinto mia madre a traslocare sulla spinta di una volontà di rinnovamento che non mi avrebbe mai abbandonata. Dopo tanto impegno per arrivare ai comfort moderni, il matrimonio mi precipitò in un’altra situazione che per me era precaria: un appartamento in un buon quartiere ma privo di ogni comodità, almeno nel senso in cui io l’intendevo. Mi sentivo una volta di più in attesa di una svolta, del dono di uno spazio congeniale, del piacere effimero della bellezza. E infine potei entrare trionfalmente nella casa che avevo sempre desiderato, ampia, un po’ oppressa dalle pesanti decorazioni ottocentesche, ma elegante e rassicurante. Era perfino più di quello che avevo immaginato. E infatti ben presto mi trovai ad aggirarmi per le stanze, smisurate per una giovane coppia, oppressa dai sensi di colpa per aver osato desiderare e per aver ottenuto quello che volevo senza aver pagato in sacrifici e dolori, che puntualmente arrivarono sollevandomi un poco alla volta dal giogo del privilegio. Nella quinta casa entrai, tra mille dubbi e incertezze, in un momento in cui, nella convulsione della vita professionale che cercavo di consolidare, l’abitazione era l’ultimo dei miei pensieri. Il fatto che, per la prima volta in vita mia potessi vivere in una casa di proprietà mi consolava solo parzialmente del minor spazio a disposizione, dell’affastellamento dei mobili. Nel frattempo avevo acquistato, associandomi a un collega giovane e coraggiosamente sconsiderato quanto me, un piccolo studio in pieno Centro Storico, ancora degradato e pieno di meraviglie appena percepibili, non ancora segnato dalla beautification attuale. L’avevo voluto tutto bianco, per sopperire alla mancanza di luce dall’esterno o forse per un bisogno di assoluto, sempre inseguito e mai fatto mio fin dall’infanzia, con molta ardesia a vista, nel rispetto della tradizione genovese (Mia Genova difesa e proprietaria / Ardesia mia. Arenaria/… scriveva Giorgio Caproni) e molto giallo, il colore dei fiori sempre amati, liguri ginestre e mimose, esotici girasoli, rose di spalliera dei piccoli cimiteri costieri. Solo dopo un decennio lo studio fu abbandonato per un altro più grande, di nuovo e sempre tutto bianco, con molto legno naturale – calore/colore – parquets ovunque, librerie nere a incorniciare le centinaia di libri coloratissimi, croce e delizia della mia vita. E poi un tocco marino di blu e le finestre spalancate sui giardini dei vicini, pieni di fiori e frutti, di canna indica e di limoni. Ora vivo nella casa che potrebbe essere l’ultima, tutta volta a levante, così da riempirsi al mattino di luce dorata –che attraversa diagonalmente le stanze segnandole con strisce vibranti di impalpabile pulviscolo – e al tramonto di roseo chiarore riflesso che sembra abbandonarla con riluttanza all’oscurità. Ancora una volta è bianca e azzurra, come il mare che si intuisce in lontananza, con qualche tocco di grigio e di nero e la confortante dolcezza del legno vecchio dei mobili che la mia famiglia d’origine si trascinò dietro nel suo errare per mezza Europa, nel corso degli ultimi tre secoli. Le stanze sono grandi e ariose e abbastanza vuote da consentire di attraversarle come si attraversa una baia in un giorno di bonaccia. È uno spazio gentile e amichevole. Forse sarà il luogo dove posarsi, come il gabbiano del Poeta, smettendo di vivere “balenando in burrasca”?
Antida Gazzola
Pubblicato in La Ballata. Rivista d’arte e cultura, 1, 2011, pag. 27
Rue Gabrielle
…je me suis réveillé ce matin
pour la rose d‘un jardin
un coeur humain
encore humain
à l’appel de nos noms on revient
comme on revient
et pourquoi
juste pour connaître la fin…
Raphaël, La route de nuit, 2005
Quando arrivai per la prima volta in rue Gabrielle, a metà degli anni ’80, ero un
reduce, come molti miei coetanei. Avevamo perso la guerra del ’68 e poi quella
del ’77. E allora non sapevamo fino a che punto avessimo perso. In fondo la
maggior parte di noi aveva desiderato solo liberté, egalité, fraternité, espresse in
forme diverse da persone così differenti, da Jack Kerouac a Daniel Cohn Bendit,
dai figli dei fiori a Malcom X. In Italia il peso degli anni di piombo aveva
annegato tanti slanci sinceri verso un vero rinnovamento nella palude della paura
e del sospetto reciproco. Ciascuno di noi aveva reagito a suo modo, andandosene
all’estero, mettendo su famiglia, dedicandosi a professioni più o meno
intellettuali. Talvolta facendo tutto questo allo stesso tempo.
Ogni giovedì la casa al 29 di rue Gabrielle era aperta a tutti gli amici e conoscenti
dei padroni di casa – Françoise e Patrice, entrambi studiosi di storia, con percorsi
di vita molto diversi – senza bisogno di un invito specifico. Il piccolo giardino e
il pavillon bicentenario in condizioni precarie, sulla via di una ristrutturazione
amatoriale che non sarebbe mai finita, si riempivano di ricercatori scientifici,
artigiani di genio e di poca fortuna, giovani docenti universitari, studenti
occasionali e di lungo corso, immigrati, esuli. Lingue e accenti si intrecciavano in
una Babele vibrante. Dalle profondità di una cave, scavata direttamente nella
roccia del mont des Martyres, salivano salumi e formaggi, birre e soprattutto vini,
generosamente messi a disposizione degli ospiti. Baguettes fragranti arrivavano
dal forno vicino. Nella sala al piano terreno il fumo di sigarette, sigari e, forse, di
qualche prodotto più esotico, creava una nube compatta.
La prima volta il mio sconcerto fu grande. Ero una saggia borsista, con una
famiglia in Italia, astemia, incapace di accendere una sigaretta. Con la mia gonna
grigia a pieghe, il golfino rosa e i lunghi capelli intrecciati, dovevo essere
l’immagine del rinascente conformismo e del più oscuro provincialismo. Ricevetti
qualche occhiata di sbieco, raccolsi qualche sorrisetto. Solo Françoise, piccola
erinni strabica e ricciuta, paludata in lussuosi abiti da rigattiere, aveva intuito la
mia persistente ribellione interiore, il mio sotterraneo bisogno di capire quello che
mi stava intorno. Era quello che ci univa, insieme a un profondo rispetto per il
nostro lavoro e a un rigore morale che talvolta non corrispondeva alla morale
comune.
Dopo quella volta, per i successivi 25 anni frequentai spesso la casa di
Montmartre. Per un certo tempo vi ho avuto una “mia” cameretta, un “mio” letto
(un bel mobile a barca dell’ottocento con lenzuola e imbottita rosso porpora) dal
quale, attraverso una finestrella potevo vedere la gente salire e scendere da Place
du Tertre, per una scalinata famosa in tutto il mondo e mille volte fotografata, con
ogni tempo.
Ogni tanto anche mio figlio dormiva in una brandina accanto a me. Al mattino
Patrice tagliava sottili strisce di pane per invogliare il mio bambino disappetente a
mangiare e gli raccontava bellissime storie in francese che, a lungo, il piccolo
interlocutore non capì. Alle soglie dell’adolescenza, fu là che durante una cena
con studiosi di mezzo mondo delle più varie discipline, bevve il suo primo
bicchiere di vino puro, nonostante le mie deboli rimostranze. Quando Patrice morì
in un tragico incidente, per mio figlio fu il primo amico che scompariva, la prima
esperienza diretta che la morte esisteva e cancellava presenze, se non ricordi.
Più tardi, ormai studente della Sorbonne, dormì per qualche tempo nel letto che
avevo spesso occupato io, ascoltò tati Françoise parlare e cantare con la sua bella
voce da mezzo soprano, fu corretto infinite volte fino a che il suo francese fu
davvero tale, come era successo a me tanti anni prima.
Scomparso Patrice che quella casa aveva curato, nutrito di attenzioni e di piccoli
lavori, cominciò un’altra epoca più malinconica e faticosa.
Ci furono meno risa, meno spumeggiante convivialità, ma gli amici e i conoscenti,
gli allievi e i collaboratori, avevano continuato ad avvicendarsi, attratti dal fascino
del luogo e dalle opportunità di incontro e soprattutto dall’indomabile vivacità
intellettuale della padrona di casa. Le stanze si erano intanto riempite sempre più
di scatole di archivi storici raccolti in tutta la Francia. Il lavoro era rimasto l’unica
sicurezza, l’estrema risorsa di fronte a una teoria di perdite.
Ora che Françoise non c’è più, la casa diventerà forse sede di una Fondazione e
sarà ancora una volta frequentata da studiosi di mezzo mondo ignari che brandelli
della mia vita, come di quella di molti altri, sono rimasti appesi là attorno alle
vetrate che affacciano su di un vivo rettangolo d’erba e di piante selvatiche.
Antida Gazzola
Pubblicato in La Ballata. Rivista d’arte e cultura, 2/3, 2015, pag. 25
Sulle sponde dell’Île d’Orléans
Avevano ragione gli indiani algonchini che la chiamavano “Ouindigo”, luogo fatato. Questa isola
lunga 34 km e larga 8, soavemente ormeggiata nel mezzo del fiume Saint Laurent come un
gigantesco battello, sembra essere il prodotto di molteplici sortilegi. Quando la scoprì, nel 1535,
Jacques Cartier la chiamò, in un primo momento, “l’isola di Bacco” perché fu colpito dalle viti
selvatiche che la coprivano, fatto non banale se si considera la regione fredda in cui si trova, in
mezzo a un corso d’acqua che gela in gran parte per lunghi mesi. Più tardi lo stesso Cartier le diede
l’attuale denominazione in onore del duca d’Orléans, figlio del re di Francia Francois I.
Il microclima favorevole ha sempre consentito la coltivazione di legumi, patate, fragole, uva,
piccoli frutti, mele accanto al tradizionale acero e la percezione che ne deriva è quella di un
gigantesco, ordinatissimo orto – giardino, curato quanto quello che Louis XIV aveva voluto a
Versaille.
Sull’isola ci sono sei villaggi che ospitano circa 7000 abitanti durante la maggior parte dell’anno e
circa il doppio durante l’estate : Sainte-Famille, Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, Saint-Jean-de-
l'Île-d'Orléans, Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans e Sainte-Pétronille,
all’estremità sud-ovest, proprio di fronte alla città di Québec.
Sulla punta di Sainte Pétronille, quasi al bordo del grande fiume che scorre poderoso ed è scosso
dalle maree che lo fanno ritrarre ed avanzare al ritmo lunare abbracciando l’isola e ritraendosene
come in una danza prevedibile e insieme misteriosa, c’è una casa piena di meraviglie.
Ad ogni tramonto, dalle sue finestre si vedono accendersi le luci di Québec a pelo d’acqua: sembra
che, sullo sfondo, si sia immobilizzato il Rex del film di Fellini.
Nel giardino crescono piante autoctone vicino ad arbusti tropicali.
Uno specchio d’acqua ricorda un giardino zen, in cui fioriscono le ninfee e gracidano ranocchi
verdissimi. Alcuni sostegni di legno permettono agli uccellini, compreso un sorprendente colibrì, di
alimentarsi con il cibo che viene loro offerto. Le eccedenze che cadono per terra sono volentieri
raccolte da procioni con la mascherina nera intorno agli occhi come ladri da cartoni animati e la
lunga coda foltissima a righe orizzontali, che deve essere morbida come un piumino ma che,
considerato il carattere ombroso e le terribili unghie dei procioni, non è saggio provare ad
accarezzare.
Sul retro della casa l’orto è disegnato con precisione geometrica: un tappeto policromo di verdure,
di insalate, di erbe officinali, alternate a fiori e ad arbusti. Nessun miracolo. E’ il prodotto di
un’orticultrice di grande esperienza e di padroni di casa dalle idee chiare e dai gusti raffinati, ma il
risultato è affascinante. È uno di quei luoghi in cui si potrebbe restare per ore non facendo altro che
guardare e lasciarsi penetrare dalla bellezza fino ad esserne storditi.
Gli unici suoni sono quelli del Saint Laurent che scorre, degli animaletti che frequentano il luogo,
delle foglie che stormiscono. La musica naturale cambia dal sussurro delle belle mattinate estive al
crescendo drammatico dei giorni di tempesta in cui i rami degli alberi frustano l’aria con sibili
sinistri e la pioggia batte sulle foglie “con un crepitío che dura/e varia nell'aria/ secondo le fronde/
più rade, men rade” come avrebbe detto D’Annunzio.
Al Vate sarebbe piaciuto anche l’interno della casa, le sue collezioni di oggetti quotidiani o rari, la
piccola orangerie in cui soffermarsi a leggere in mezzo a piante di orchidee sospese e un
arredamento dolcemente fin de siècle. Molti mobili dell’arredamento appartengono a quel
particolare momento all’inizio del ‘900 in cui furono prodotti oggetti spesso pieni di grazia, in
contrasto – o forse a compensazione – delle burrasche politiche e sociali che squassavano il mondo.
Alcuni sono più antichi, altri sono più moderni, ma l’insieme fa pensare a cure e a buoni sentimenti,
a valori antichi, alla volontà di circondarsi, per quel che si può, della serenità trasmessa dalle cose
che vivono insieme a noi, che ci arricchiscono, che ci servono, che ci appartengono senza chiedere
nulla, tranne una spolverata ogni tanto.
Nel salone principale il caminetto scalda non solo i giorni invernali ma anche le ore estive più
fresche.
Se si guarda bene tra le fiamme, in questo luogo magico, si vedono passare gli indiani avvolti nelle
loro pellicce, i pii coloni francesi che edificarono tante rustiche chiese, gli invasori inglesi che
costruirono case così aggraziate. I turisti prepotenti e gli speculatori non sono considerati. I
visitatori rispettosi e succubi del fascino dell’isola possono restare e assopirsi al calore delle braci
mentre il grande fiume continua il suo instancabile viaggio.
Antida Gazzola
Pubblicato in La Ballata. Rivista d’arte e cultura. 1, 2014, pag. 25
Il Louvre- Lens
Avec un ciel si bas qu´un canal s´est perdu
Avec un ciel si bas qu´il fait l´humilité
Avec un ciel si gris qu´un canal s´est pendu
Avec un ciel si gris qu´il faut lui pardonner
Avec le vent du nord qui vient s´écarteler
Avec le vent du nord écoutez-le craquer
Le plat pays qui est le mien.
Jacques Brel, Le plat pays
Nel profondo Nord della Francia, poco lontano dalla Manica, in un paese di brume, acqua e infinite
declinazioni di verde intenso, si trova Lens, antica città mineraria. Qui si è estratto il carbone per tre
secoli fino a che, nel 1990, tutto il sito minerario è stato chiuso. L’attività estrattiva ha modificato
profondamente il paesaggio che oggi appare costellato da curiose collinette, perfettamente coniche,
formate dai detriti della lavorazione del minerale. Ogni elevazione evoca per contrappasso un
titanico scavo, come alla ferocia dello sfruttamento corrispose la pena di un lavoro da cui tanti si
aspettarono un avvenire troppo spesso interrotto da morti repentine o dolorosamente lente. Intorno
all’antica miniera restano centinaia di abitazioni unifamiliari, in passato residenza di tutti i
lavoratori. I tipi edilizi cambiavano a seconda del livello sociale, dai semplici operai ai direttori di
stabilimento. Il mondo umano della miniera viveva a stretto contatto: classi e ceti si affiancavano e
tutti passavano la loro vita a lato delle voragini che consegnavano a fatica il prezioso minerale
chiedendo in cambio una dedizione che molte volte diventava sacrificio della vita. In omaggio a
questa epopea la prima pietra del Louvre-Lens fu posta il 4 dicembre 2009, giorno di Santa Barbara,
protettrice dei minatori.
Dopo la chiusura della miniera, negli anni sessanta, le autorità locali avevano cercato a lungo una
soluzione per l’utilizzo di quell’immenso spazio che sprofondava per quasi un chilometro sotto
terra. Nel 2003, il Louvre di Parigi annunciò di cercare un sito in cui collocare una parte dei propri
tesori, raccolti dal momento della sua istituzione nel 1793. La localizzazione doveva essere
decentrata rispetto a Parigi e lo spazio espositivo assolutamente contemporaneo. Fu accolta la
candidatura di Lens per molti motivi: non c’era un museo, l’area era stata profondamente colpita
dalla deindustrializzazione e rischiava l’agonia economica e sociale, il passato di durissimo lavoro
meritava bene un riscatto che trasformasse quei luoghi di dolore e di fatica in luoghi di incontro con
l’arte, con la bellezza, con le più sublimi capacità espressive.
Il progetto che vinse il concorso di idee per il nuovo museo fu quello dello studio giapponese
SANAA che ha dimostrato una straordinaria sensibilità nell’interpretare i luoghi naturali e le
preesistenze.
Ora un edificio di aspetto leggerissimo – bianco opaco e vetro trasparente – sembra essere posato
come un origami su una vasta estensione piatta come una mano, progettata dalla paesaggista
Catherine Mosbach e coperta da segni circolari che trattengono un po’ della pioggia che qui cade
spesso, micro bacini, specchi naturali in cui si riflettono le nuvole che corrono negli infiniti cieli di
pianura. Dopo secoli di carbone che ha sporcato visi, mani, abiti, coscienze, tutto è lieve, candido e
dolcemente mutevole.
All’interno, negli strati in profondità, sono stati collocati numerosi servizi riguardanti la gestione, il
recupero, la manutenzione, il ricovero di tante meraviglie di proprietà del Museo. Nella parte in
elevazione si trovano gli spazi comuni (reception, libreria, luoghi di sosta, caffè) in cui, complice la
luce fredda e argentea proveniente dall’esterno, filtrata dall’umidità che persiste in ogni periodo
dell’anno, galleggiano i visitatori, unica macchia di colore che anima l’atmosfera rarefatta di quei
luoghi.
Tutti possono visitare (gratuitamente, come capita in tutti i Paesi civili) la “Galleria del tempo” in
cui si è messi a confronto con opere che attraversano 5000 anni della storia umana. Le pareti della
Galleria sono rivestite di alluminio anodizzato che distribuisce la luce in modo morbidamente
omogeneo. Le opere sono collocate in modo che ci si possa girare intorno e sono in parte rivolte
verso chi entra e in parte verso chi ritorna indietro in un moltiplicarsi vertiginoso di percezioni.
All’inizio del percorso si può trovare una tavoletta del 3500 a.C. incisa con scrittura cuneiforme o la
statua di un re di Babilonia del 1900 a.C., si possono poi ammirare la “Vergine e il Bambino” di
Botticelli, il ritratto di Baldassarre Castiglione di Raffaello, il San Sebastiano del Perugino – solo
per citare i maestri italiani – e due centinaia di altre opere, per poi concludere di fronte alla grande
tela di Delacroix con la Libertà che guida il popolo.
In dubbio sulle possibilità di “égalité”, lo storico motto francese potrebbe essere qui declinato come
“Liberté, beauté, fraternité”, poiché se la cultura è parte integrante della libertà di cui è origine e
conseguenza, la bellezza è una gioia e un sollievo disponibile per chiunque abbia la possibilità di
coglierla e può moltiplicare i suoi effetti quando è condivisa. Quelle differenze sociali così marcate
nel modesto spazio abitativo intorno al nuovo edificio si stemperano nella fruizione insieme del
tutto soggettiva e collettiva dei visitatori accomunati dalla meraviglia di fronte ai preziosi contenuti
del Museo che rappresentano l’umanità intera nel tempo e nello spazio.
Per approfondimenti: www.louvrelens.fr
Antida Gazzola
Da quasi vent’anni affianco alla mia attività di sociologa urbana in campo scientifico quella di collaboratrice della rivista di arte e cultura “La ballata”. La mia rubrica si chiama Walking about. Il titolo evoca percorsi e viaggi in luoghi più o meno lontani. I testi descrivono edifici, città, territori e le sensazioni, le memorie, le riflessioni da essi suscitate.
Pubblicato in La Ballata. Rivista d’arte e cultura, 2, 2007, pag. 27
Per antiche scale
Una pioggia leggera lacrima dolcemente su Finalborgo, luogo incantato al centro della riviera ligure
di ponente. Da Final Marina, sulla costa, si entra per un paio di chilometri all’interno, per una via
con marciapiedi ben lastricati e costeggiata da edifici dignitosi.
Sul lato orientale sono annidate alcune vecchie ville con bei giardini un po’ disordinati, verdissimi contro lo sfondo aspro e grigio
dei monti. Il borgo giace all’interno delle sue mura medioevali. La ricchezza dei colori, dei decori,
delle stratificazioni secolari di segni architettonici fanno sembrare la piccola piazza centrale una
scena teatrale, vera perché allusiva di una verità storica, ma certamente diversa dalla realtà che ci è
consueta.
Ci si aspetta che le persone che si incontrano su quel palcoscenico naturale siano attori e
come tali si comportino. Naturalmente non è così, ma ci vuole un po’ di tempo per abituarsi all’idea
che la vita quotidiana attuale trovi spazio in un posto apparentemente così poco segnato dallo
scorrere degli anni. E’ una sensazione simile a quella offerta da Sabbioneta che, tuttavia, è ormai
deserta di residenti e sottratta agli usi quotidiani. Venezia è incomparabile, per la diversità di taglia
con il piccolo borgo e il degrado penosamente avanzante. Populonia forse ha visto origini ed
evoluzioni simili, per la precocità dell’antropizzazione e il suo continuo lavorio, nei millenni, sul
sito, oggetto di costanti opere, investimenti e insediamenti umani. Ora, però, la bella rocca
compresa tra le possenti fortificazioni dei d’Appiano è diventata un giocattolo turistico. A
Finalborgo i turisti ci sono, ma abbastanza diluiti tra gli abitanti, almeno nei giorni feriali. Alcuni,
come me, sono visitatori particolari, attirati più che dall’atmosfera o dai prodotti gastronomici locali
– pur rispettabilissimi – dal singolare complesso di Santa Caterina, nato, alla metà del 1300, come
convento. Mi lascio alle spalle la giornata grigia e penetro in un mondo caldo di bei colori terrosi,
con pavimenti in pietra locale di una sfumatura rosata. Gli spazi sono ampi e grandi sale libere da
inciampi sono a disposizione di mostre di arti figurative. I due chiostri rinascimentali evocano pace
e letizia di studi e meditazioni. Mi chiedo, come sempre in luoghi simili, che cosa dovesse essere
avere un rifugio in cui poter scrivere, leggere, riflettere in epoche ruggenti di guerre e calamità, in
fondo non così dissimili da quelle di oggi se non nelle tecnologie impiegate. Una parte del
complesso è occupata dal Museo Archeologico del Finale che presenta fascinosi reperti della più
che millenaria presenza umana in questa parte della Liguria. Vasi, vetri, gioielli, utensili, oggetti ci
raccontano un passato che è anche nostro, che sento mio. Molte cose sono splendide, ma nulla mi
turba come la sepoltura preistorica di una donna sotterrata, in posizione fetale, con un minuscolo
bimbo accanto, forse morto con lei, durante o subito dopo il parto. Nessuna cosa può avere la
capacità evocativa di queste due persone che, pur nella morte, esprimono tutta la forza e il mistero
della vita. Lo scheletro della donna, disposto pietosamente intorno al corpicino del figlio, mi pare
l’immagine stessa della maternità, dell’amore illimitato che lega madre e figli, della simbiosi e della
protezione uterina, di quel periodo della nostra esistenza in cui nessuno di noi è solo perché fa parte
di un altro. La morte ha impedito che entrambi sperimentassero l’avventura gloriosa e rischiosa
della libertà che segue al distacco. Sono rimasti fissati in una tenera prossimità che attraversa il
tempo e mi colpisce anche se le mie sensazioni sono certo segnate dalle contorsioni della modernità,
da acquisizioni provenienti da filosofia, psicanalisi, letteratura e da quanto altro fa parte del
percorso culturale che ho compiuto. Mi allontano a fatica, silenziosamente.
Passare da un luogo all’altro del complesso consente, attraverso le finestre, panorami inattesi e
seducenti. Guardare fuori completa quello che si vede all’interno e lo arricchisce. Uno scorcio
verticale permette di cogliere simultaneamente uno dei cortili interni con tracce romane, un po’ più
in alto una parte del convento e, ancora più in alto, una parte di Castel San Giovanni. Penso agli
affreschi di Masaccio, di Giotto, alle loro architetture armoniosamente a-prospettiche.
Scendo nella grande chiesa dove forse aleggiano gli spiriti dei del Carretto, che vollero il convento
e che vi furono sepolti. In questa navata, per le sale e i corridoi sono risuonati, nei secoli, molti
passi pesanti di guerrieri di ogni epoca. In diverse occasioni – anche in periodi relativamente
recenti – ai monaci si sostituirono i soldati. Il cambiamento non giovò né ai luoghi né agli occupanti.
Perfino nel campanile furono ricavate celle di detenzione. Mi arrampico su per le strette scale che
devono essere state salite da persone colpevoli o innocenti, rassegnate o disperate, tranquille o
rabbiose, verso i minuscoli loculi arredati solo con una panca di pietra, con lo spazio appena per
stare ritti, toccando da un lato il sedile, dall’altro il muro e, per i più alti, con la testa il soffitto.
Niente finestre. La sola apertura era la porta, massiccio sipario di metallo tra la vita di fuori e la
non-vita di dentro. Eppure il campanile ha bucature aperte sull’ incantevole campagna circostante.
È una condizione degna dell’immaginazione dantesca: salendo, da ogni apertura che dà sull’esterno
si può godere di quello che si sta per lasciare, che si sta per perdere senza sapere per quanto tempo,
una volta rinchiusi nel luogo della pena. Pareti e porte sono segnate da graffiti lasciati dagli antichi
carcerati: frasi, invocazioni, imprecazioni, schematici calendari per tener conto dei giorni che
passavano. Da fuori saranno arrivati sghembi raggi di luce del sole o della luna, il rumore della
pioggia, muggiti, belati, il latrare dei cani, il canto dei galli e degli uccelli, le voci degli uomini
liberi. Da dentro si saranno diffusi lamenti, imprecazioni, domande. E questi suoni saranno planati
su quella meraviglia sottostante, ancora straziata, violata, offesa da un uso improprio e nefasto.
Ora che la pace e la bellezza sono stati ripristinati in basso, segni e parole, qui in alto, continuano a
parlare del dolore e della sopraffazione, da qualunque parte venissero, chiunque fosse il colpevole.
Sono una ulteriore prova dell’imprescindibile necessità dell’uomo di comunicare, in primo luogo
con se stesso, e poi con altri, perfino con sconosciuti di cui non si sa neppure se e quando potranno
leggere quegli scritti. Quale migliore metafora della vita? Si scalano faticosamente gradini già
percorsi da molti altri, ma con un passo che è solo nostro, verso luoghi di solitudine ma contigui ad
altri spazi di isolamento. Fuori il mondo splende di bellezze e possibilità. Dentro, il nostro mondo
interiore, popolato di percezioni, saperi, emozioni, cerca la strada per travasare qualcosa nella
mente di un altro. Forse ognuno di noi, anche in situazioni meno estreme, vorrebbe lasciare una
traccia su un muro che possa essere letta da qualcuno, stabilendo un contatto con l’Altro, alla
ricerca del cortocircuito che lo ricondurrà a sé. In fondo tutti abbiamo bisogno di amore o, almeno,
di essere visibili, riconosciuti e di coltivare la speranza di essere ricordati.
Questo mondo fragile,
un istante che ci è offerto…
più che tutte le parole dell’uomo, dopo tutto,
è questa lettera che io ti dico,
che io ti scrivo con tutto me stesso
e che non sarà mai finita …
I versi, tratti da “Elsa”, sono di Louis Aragon
Sito del Museo Archeologico su cui si possono trovare vari approfondimenti: www.museoarcheofinale.it.
09 Scienze Sociali, Politiche e della Comunicazione
Luca Raffini
La crisi, prima e dopo la pandemia Covid-19
La pandemia Covid-19 è un evento inaspettato, che ha cambiato profondamente la nostra vita quotidiana, e che avrà impatti sul futuro. Cosa avverrà dipenderà in primo luogo da noi, dalla nostra capacità di reagire, ma ancor prima dalla nostra capacità di capire cosa la pandemia ci dice su ciò che siamo stati fino ad oggi e cosa vogliamo essere da domani. Di riflettere su cosa è entrato in crisi oggi e su cosa era già in crisi, e la pandemia ci evidenzia in modo drammatico.
Una cosa è certa. Concentrandoci sull’Europa e l’occidente, al di là del suo aspetto sanitario, la pandemia ha toccato i nervi scoperti del nostro modello sociale, economico, politico e culturale.
Ci interroga sui nostri modelli produttivi e di consumo, sulla loro sostenibilità e sulla vulnerabilità che producono. Sull’equilibrio tra libertà, uguaglianza e giustizia, tra diritti e responsabilità, tra interesse privato e interesse collettivo.
Su un modello di sviluppo, quello neo-liberista, che pone la priorità sulla massimizzazione del profitto, sull’aumento della produzione e del consumo, sulla libertà di impresa e sul rispetto dei parametri economici e finanziari, al prezzo di aumento delle diseguaglianze e di riduzione dei diritti e delle tutele individuali. Su democrazie sempre più appiattiti su questi imperativi, cui fanno da contraltare movimenti e partiti sovranisti e populisti, che allo slogan “non c’è alternativa” dei primi, oppongono risposte che fanno leva sulla paura e sul bisogno di protezione, alimentando una guerra tra poveri che ha l’effetto di distogliere l’attenzione dalle cause reali e profonde della crisi economica, sociali politica che, a ben vedere, ci accompagna da anni.
È così, per esempio, che le scelte effettuate dal governo italiano, di chiudere scuole e università, ma non le attività produttive, se non a pandemia ormai ampiamente diffusa – scelta che ha, con ogni probabilità, contribuito alla stessa – ci spingono a chiederci quali siano le nostre priorità. Una risposta chiara, in tal senso, è quella data da Boris Johnson, che ha detto ai suoi concittadini di abituarsi all’idea di perdere dei loro cari. Ma l’economia può essere fermata. Johnson, come Trump, è stato presto costretto a cambiare idea, ma solo perché hanno capito che il prezzo economico di un mancato lockdown sarebbe stato ancor più alto.
La pandemia ci ha insegnato anche che il nostro sistema sanitario, pubblico, da decenni ritenuto ai vertici tra i paesi sviluppati, ha retto efficacemente anche nei momenti più duri. Grazie all’abnegazione di medici e infermieri, ma anche grazie a una struttura ancor oggi ben più solida e universalista, nonostante tutto, di sistemi come quello statunitense. Ma ci spinge anche a riflettere sulle conseguenze dei tagli alla sanità e delle privatizzazioni, evidenziate, per esempio, dalla riduzione dei posti letto in terapia intensiva.
La pandemia ci dice molto altro.
Ci parla della crescente forbice tra tutelati e non tutelati. I dipendenti pubblici e privati, da una parte, che hanno potuto usufruire dello smart working, continuando a lavorare a casa, nella continuità stipendiale, i lavoratori costretti a continuare regolarmente il proprio lavoro, in condizioni di forte rischio – non solo il personale sanitario, ma anche gli addetti ai trasporti, alla logistica, alla distribuzione. Tra questi i corrieri e i riders, questi ultimi, in particolare, privi di qualsiasi forma di tutela e di protezione. E, infine, tutti quei lavoratori che con il lockdown hanno immediatamente perso – o visto fortemente ridursi – ogni fonte di reddito. Tra questi, le partite iva, i precari, i lavoratori irregolari, che non godono quindi dell’accesso agli ammortizzatori sociali. Insomma, uno straordinario acceleratore di diseguaglianza.
E che dire della mobilità radicale a cui ci eravamo abituati? Chi, fino ad ieri, era abituato a muoversi regolarmente in ambito nazionale ed internazionale, si trova oggi, improvvisamente, nelle condizioni di dovere compilare un’autodichiarazione per uscire a fare la spesa. È possibile pensare che, nell’arco di qualche mese, tutto ricominci come prima? Rivedremo le nostre città, oggi spettrali, invase da torme di turisti, provenienti da tutto il mondo? Da una parte speriamo di sì: la scomparsa del turismo significa, per moltissimi italiani, perdere la principale fonte di sostentamento. Non solo gli addetti al settore turistico e dell’accoglienza, di tipo tradizionale, ma anche chi affitta su AirBnB, ecc. Un’altra parte di noi ha chiaro che la mobilità frenetica a cui siamo abituati non è sostenibile.
Ce lo dicono il ritorno dei pesci e dell’acqua trasparente nei canali di Venezia, il rapido miglioramento dell’aria nella pianura padana. Il fatto che, in molti di noi, osservando il traffico ridotto delle nostre città, abbiano pensato quanto gli piacerebbe che fosse sempre così.
E cosa ci insegna, essere costretti all’immobilità, rispetto al rapporto con gli altri? Con i vicini, con il quartiere? A sviluppare una maggiore vicinanza, una maggiore solidarietà, un più spiccato senso di comunità? In molti casi si. In altri, si è sviluppato un clima di diffidenza e di caccia agli untori che, al contrario, tende a mettere tutti contro tutti.
Questo a livello di relazioni quotidiane, ma a ben vedere questo tipo di riflessione vale anche nel rapporto con la politica. La crisi ci spinge a un maggiore bisogno di confronto, di partecipazione, di collaborazione, o alimenta un clima di diffidenza di paura che ci spinge a cercare protezione in un leader carismatico, e a sfogare le nostre ansie cercando capri espiatori?
Anche su questo piano, a ben vedere, la pandemia non fa altro che alimentare tendenze già in atto.
In questi giorni circola la frase “Non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema”.
Un modo efficace per sintetizzare la consapevolezza che dietro la crisi della pandemia c’è una crisi più profonda che non possiamo non recepire.
È il momento di ripensare profondamente cosa ci piace e cosa non ci piace della società in cui abbiamo vissuto fino a poche settimane fa, prima di correre a testa bassa per tornare a metterla in scena.
Vogliamo che il mercato, il profitto, la produzione e il consumo rimangano le priorità nell’agenda politica? L’UE ha deciso di sospendere il patto di stabilità e di concedere agli Stati di produrre liquidità, alzando il debito, ma cosa avverrà al termine della pandemia? Torneremo a perseguire la politica dell’austherity? O questo implica un cambio profondo di orientamento?
Vogliamo un welfare capace di accogliere e proteggere tutti i cittadini, anche nell’emergenza, o un welfare modellato sulle esigenze economiche?
Vogliamo una società che costruisce la sicurezza nella partecipazione e nell’accoglienza o nell’isolamento e nella protezione l’uno contro l’altro?
Vogliamo perseguire una crescita cieca o pensare seriamente alla questione della sostenibilità?
Vogliamo una mobilità – per turismo e per lavoro – sempre più radicale, perché funzionale alla crescita dell’economia, o vogliamo pensare una mobilità socialmente ed ambientalmente sostenibile? E oggi, che siamo tutti costretti all’immobilità, riusciamo a comprendere meglio la tragedia delle migrazioni forzate?
Vogliamo, e crediamo, nella prospettiva di una Europa Unita, o crediamo che la ricostruzione dei confini nazionali sia una risposta?
La crisi non è finita, e, soprattutto, non sono terminate le sue conseguenze. Può essere il detonatore che ci porta a una crisi senza ritorno, ma può anche rappresentare l’occasione per fermarci un momento a riflettere, e per portarci dietro alcune cose che abbiamo appreso.
Non da ultimo, a valorizzare e a integrare nella nostra vita quotidiana le opportunità che ci offrono i media digitali per rimanere in contatto e per portare avanti le nostre attività. Dalle video-lezioni alle video-telefonate con gli amici, dalle ricette mediche online ai servizi di e-government e di home banking.
La crisi del Covid-19, insomma, ci ha costretti a modificare il nostro stile di vita, a rallentare i nostri ritmi, e quindi a guardare con un po’ di distacco alle nostre abitudini. Può essere un’occasione per pensare che forse, davvero, un altro mondo è possibile, come recitava un’ormai vecchio slogan di movimento.
un caro saluto
10 Diritto, Economia e Welfare
Marco Doria
Genova è un luogo particolarmente adatto per ricordare la Liberazione e la Repubblica; la nostra città, medaglia d’oro della Resistenza, seppe liberarsi da sola dal giogo nazifascista. È noto che quando le truppe alleate entrarono finalmente in città, non dovettero liberarla, ma la trovarono già tornata alla normalità della pace, con le linee di trasporto pubblico funzionanti.
Ma ricordare la Liberazione non significa soltanto richiamare un passato glorioso, quando i ragazzi e le ragazze di allora opposero il loro coraggio e il loro desiderio di libertà alla crudele occupazione nazista e agli ultimi tragici sussulti della dittatura fascista. E vinsero, dimostrando che se un popolo vuole veramente la libertà e lotta per realizzarla, nessun regime, per quanto oppressivo, è in grado di negargliela.
Uniauser Genova, attraverso un bellissimo intervento di Marco Doria (che trovate sul nostro sito attivando il link ……. ), vuole celebrare il 25 aprile per proiettare nel presente e nel futuro i valori della Liberazione per i quali le generazioni che ci hanno preceduto seppero combattere e morire.
Ringrazio Marco per la sua grande disponibilità e auguro a Voi tutti un Buon 25 aprile
Michele Cozza (Presidente Uniauser Genova)